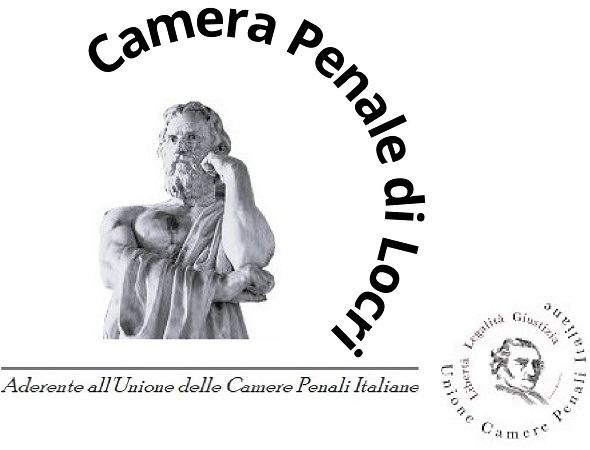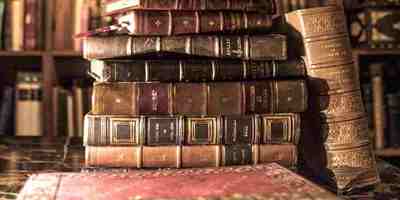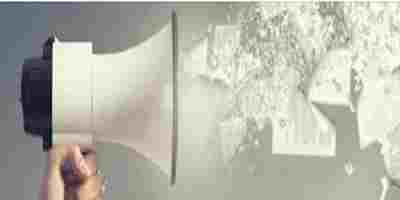“Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, nel caso in cui l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, venga successivamente sottoposto, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., a nuova applicazione della custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell’istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.”
A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)
Il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di un soggetto accusato (insieme ad altri co-indagati) dei reati di omicidio volontario aggravato, di tentato omicidio aggravato (capo 1), di detenzione e porto illegali aggravati di una pistola calibro 9×21 (capo 2) e del reato di cui agli artt. 110, 112, n. 1), c.p., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1. c.p. (capo 3).
Il Tribunale del riesame di Napoli, pronunciandosi sull’appello proposto ex art. 310 c.p.p. dal P.M. avverso la suindicata ordinanza reiettiva, accoglieva parzialmente l’impugnazione disponendo l’applicazione della custodia in carcere nei confronti dell’indagato per i reati di cui ai capi 1) e 2) “quanto meno a titolo di concorso anomalo” e per il reato di cui agli artt. 56 c.p. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (cosi qualificata la contestazione di cui al capo 3) previo riconoscimento della circostanza aggravante di cui all‘art. 112, n. 1), c.p..
Nel frattempo, una volta procedutosi al rinvio a giudizio dell’accusato, il medesimo veniva assolto dal G.U.P. presso il Tribunale di Napoli – avendo optato per il rito abbreviato – da tutti i reati allo stesso ascritti con la formula “per non aver commesso il fatto”. Nella medesima occasione, il G.U.P. dichiarava la cessazione ex art. 300, comma 1, c.p.p. della misura cautelare in corso.
Proposto appello da parte dell’organo inquirente avverso la sentenza di primo grado, la Corte di assise di appello di Napoli – previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente ex art. 116, secondo comma, c.p. – condannava l’imputato alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione poiché ritenuto responsabile del reato di omicidio volontario aggravato, di lesioni personali aggravate, di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo aggravati, di tentato acquisto aggravato di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana.
Considerato il drastico “capovolgimento” dell’esito processuale, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, depositava richiesta di emissione della misura della custodia in carcere nei confronti dell’imputato stante la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma contenuta nell’art. 275, comma 2-ter, c.p.p. poiché la condanna afferiva un delitto tra quelli previsti dall’art. 380, comma 1, c.p.p.. Inoltre, secondo il Procuratore generale, risultavano sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. b) e c), c.p.p. non solo per la gravità della pena irrogata, ma anche per la recente emissione nei confronti dello stesso soggetto (in diverso procedimento penale) di una ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere per i reati previsti dagli artt. 416-bis c.p., 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per numerose ipotesi delittuose in materia di stupefacenti.
La Corte di assise di appello, in accoglimento della richiesta del Procuratore, disponeva l’applicazione della misura cautelare custodiale.
Ciò posto, il cautelato, per il tramite del difensore, proponeva riesame avverso la predetta ordinanza.
Il Tribunale di Napoli – quale giudice del riesame – dichiarava inammissibile l’impugnazione considerato che l’impugnazione proposta (da intendersi come appello e non come richiesta di riesame) era priva dei relativi motivi.
L’imputato proponeva, di conseguenza, ricorso per Cassazione lamentandosi dell’errata applicazione degli artt. 275, 309 e 310 c.p.p. stante “la diversità dell’ordinanza impugnata rispetto a quella genetica, poi caducata, in quanto, con l’ultima, il concorso nel delitto di omicidio era stato qualificato come anomalo e non pieno: trattandosi di titolo di reato “diverso”, l’ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli avrebbe dovuto considerarsi “genetica” della misura da essa applicata e, pertanto, suscettibile di essere impugnata con istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.. Il ricorrente faceva leva, inoltre, sul mancato utilizzo, da parte del Procuratore generale richiedente e della Corte emittente, del termine «ripristina», essendo utilizzati, viceversa, i termini «emette» e «applica». Aggiungeva, infine, che nella stessa norma richiamata dal Procuratore generale di Napoli (art. 275, comma 2-ter, cod. proc. pen.) non si parla di ripristino della misura, ma di «disposizione» della stessa.”
La Prima sezione, investita del ricorso, con ordinanza datata 10 aprile 2024, ha preliminarmente rilevato la sussistenza di contrasto interpretativo in ambito giurisprudenziale optando, pertanto, per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite e formulando la seguente questione di diritto: “Se l’imputato – nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia in carcere che ha perso efficacia a causa del proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado – debba impugnare con l’istanza di riesame ovvero con l’appello cautelare l’ordinanza con la quale sia stata disposta la custodia cautelare in carcere, ai sensi dell‘art. 300, comma 5, cod. proc. pen., emessa a seguito di successiva condanna pronunciata all’esito del giudizio di appello”.
Il problema che concretamente si pone attiene la corretta qualificazione del mezzo di impugnazione esperibile e, precisamente, se trattasi di richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. o di appello ex art. 310 c.p.p..
Secondo un primo orientamento, devesi rilevare che “l’esegesi di legittimità tradizionale emergente appare favorevole all’esperibilità dello strumento dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. Tale linea interpretativa, si rileva, considera persistente – pur quando si sia registrata la perdita di efficacia (non di validità in base a un apprezzamento discrezionale) del primigenio titolo cautelare in ragione dell’assoluzione dai reati che ne avevano determinato l’emissione – il legame tra il provvedimento caducato e quello sopravvenuto, argomentando nel senso che quest’ultimo non può essere inquadrato come un nuovo provvedimento coercitivo, ma come la “reviviscenza” del primo, dato il nesso necessario e indissolubile che lega l’ordinanza c.d. ripristinatoria a quella che ha disposto la precedente misura” (cfr. Sez. 5, n. 32852 del 05/07/2011, Nigro, Rv. 250579; Sez. 1, n. 23061 del
12/02/2002, Leuzzo, Rv. 221636).
È, ancora, esperibile l’appello ex art. 310 c.p.p. avverso l’ordinanza con cui il giudice procedente –
contestualmente alla emissione della sentenza di condanna – abbia proceduto a una modifica in peius del trattamento cautelare dal momento che “persistendo il titolo originario, la modifica non può ritenersi titolo genetico del trattamento cautelare” (cfr. Sez. 1, n. 45653 del 05/06/2015, Pipiciello, Rv. 265486 – 01).
Secondo un secondo e minoritario orientamento, è , invece, esperibile l’istanza di riesame poiché “la misura caducata o, comunque, divenuta inefficace deve ritenersi come mai esistita e, dunque, tamquam non esset, con l’effetto che l’eventuale misura reiterativa, in quanto essa stessa “ordinanza che dispone una misura coercitiva”, è da assoggettarsi alla richiesta di riesame” (cfr. Sez. 6, n. 842 dell’’08/03/1999, Sciascia).
Secondo la dottrina, il primo orientamento (maggioritario) non affronta la quaestio iuris in modo corretto optando erroneamente per lo strumento dell’appello ex art. 310 c.p.p. dal momento che “seppure circoscritta dall’art. 300, comma 5, cod. proc. pen. alle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. b) e c), la valutazione richiesta al giudice della cautela e, poi, al giudice dell’impugnazione cautelare deve esprimersi in una nuova e autonoma disamina di tali esigenze, da compiersi anche alla stregua di tutti gli elementi sopravvenuti, per come emersi nel corso del processo, in correlazione con quanto previsto dall‘art. 275, comma 1-bis, per il caso di applicazione di una misura cautelare contestualmente ad una sentenza di condanna (sempre per le esigenze di cui alle lett. b) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen.) e dall’art. 275, comma 2-ter nel caso di condanna in appello (che, infatti, richiama il comma 1-bis)”.
Il quesito superiormente esposto e sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite ha condotto la Suprema Corte – nella sua più autorevole composizione – alla definizione del medesimo nei termini, di seguito, indicati.
Dopo un accurato e analitico esame del ragionamento logico giuridico su cui si fonda il primo orientamento (maggioritario), il secondo (minoritario) e quello della dottrina (favorevole al secondo), il Supremo Collegio ha stabilito che l’imputato (che si trovi nella situazione di cui all’art. 300, comma 5, c.p.p.) deve procedere – una volta che nei confronti del medesimo sia stata disposta la misura della custodia in carcare a seguito della emissione di una sentenza di condanna al termine del giudizio di secondo grado – all’impugnazione dell’ordinanza tramite proposizione di una istanza di riesame.
Secondo le Sezioni Unite, il numero limitato di pronunce a sostegno della soluzione adottata hanno indotto le medesime a intervenire in maniera significativa per derimere ogni dubbio di sorta nella subiecta materia.
Il Supremo Collegio ha preliminarmente evidenziato l’assoluta rilevanza della norma contenuta nell’art. 300 c.p.p. stante la necessità di tutelare adeguatamente “l’incondizionato diritto della persona sottoposta a misura cautelare ad ottenere un’immediata reintegrazione dello status libertatis, in coincidenza con sentenze di proscioglimento che ribaltino la precedente valutazione di probabile “colpevolezza” posta a base della misura, ovvero che, pur avendo contenuto di condanna, pongano il permanere della misura in contrasto con il principio di proporzionalità”.
Ciò posto, il focus, nel caso di specie, si sposta sull’ultimo comma della predetta norma ossia nei casi in cui l’imputato prosciolto venga successivamente condannato per lo stesso fatto e, al contempo, sottoposto – in presenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. b) e c) – a misura cautelare.
Da una prima analisi, secondo le Sezioni Unite, “si rivela infondato il preliminare argomento sviluppato dal primo degli orientamenti ermeneutici in contrasto, secondo il quale, se il legislatore avesse inteso recidere qualunque collegamento tra la prima e la seconda applicazione della misura, la disposizione di cui al quinto comma dell’art. 300 sarebbe stata superflua, in quanto la possibilità di applicazione ex novo sarebbe stata regolata dalle disposizioni generali in tema di misure cautelari personali. La non superfluità della disposizione in esame discende, infatti, dalla necessita di dare coerente attuazione, da parte del legislatore delegato, ad una precisa direttiva proveniente dal legislatore delegante”.
Il secondo orientamento non è, al contempo, risolutivo al fine di “disinnescare” la tesi sostenuta dall’orientamento maggioritario.
Pertanto, l’intervento della Suprema Corte è partito dalla disamina di alcune critiche mosse dalla dottrina e che trovano le loro basi in alcuni pronunciamenti di legittimità al fine di dare forza al contenuto della tesi sostenuta. In tal senso, “si è, infatti, correttamente evidenziato che, in determinati casi di perdita di efficacia dell’ordinanza originaria per effetto di un “automatismo”, la concorde giurisprudenza di legittimità è orientata a reputare esperibile il mezzo dell’istanza di riesame avverso il provvedimento coercitivo successivamente adottato.” I casi in questione sono quelli dell’impugnazione avverso:
- l’ordinanza pronunciata a seguito di declaratoria di inefficacia della misura per mancata osservanza dei termini di cui all’art. 309, comma 5 e 10, c.p.p. (cfr. Sez. 3, n. 49997 del 06/11/2015, Pellegrino, Rv. 266663 – 01; Sez. 1, n. 3972 del 06/06/1996, Nicosia, Rv. 205682 – 01; Sez. 1, n. 2271 del 05/04/1996, Morra e altro, Rv. 204824 – 01);
- l’ordinanza emessa dopo l’estinzione di altra precedente, divenuta inefficace, per omesso interrogatorio dell’imputato nei cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia (cfr. Sez. 1, n. 29687 del 09/07/2003, Saraceno, Rv. 225542 – 01; Sez. 1, n. 12398 del 14/12/2000, dep. 2001, Galatolo, Rv. 218298 – 01);
- il provvedimento con cui il giudice rinnova la misura cautelare precedentemente disposta da altro giudice dichiaratosi incompetente (cfr. Sez. 6, n. 3424 del 04/10/1995, Rilande, Rv. 203323 – 01; Sez. 6, n. 2016 del 23/05/1995, Roversi, Rv. 202843 – 01; Sez. 1, n. 1608 del 15/03/1995, Sancandi, Rv. 201127 – 01).
In tutti questi casi (nonostante non siano messi in alcun modo in discussione i presupposti giustificanti l’applicazione della misura cautelare), il provvedimento emesso – a seguito del verificarsi del fenomeno della sopravvenuta inefficacia della misura inizialmente applicata – viene considerato “alla stregua di un autonomo e “nuovo” provvedimento, con il quale il giudice procedente è di nuovo chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. Avverso tale provvedimento è attivabile il rimedio del riesame e non quello dell’appello.”.
Pertanto, la soluzione al problema non è quella della verifica della sussistenza o meno di un provvedimento cautelare “nuovo” rispetto a quello oggetto di caducazione e, conseguentemente, non può assumere di decisivo rilievo “il criterio che […] ha inteso fare riferimento alla causa di cessazione dell’efficacia, escludendo il carattere di “novità” di quello emesso in seguito alla perdita di efficacia del precedente ascrivibile ad “automatismi” processuali”.
A questo punto sorge spontanea la domanda se tra gli “automatismi” processuali possa rientrare anche la sentenza assolutoria.
La risposta è negativa dal momento che “il venir meno della misura originariamente applicata a seguito della sentenza di assoluzione, in primo grado, dell’imputato non può, invero, essere considerato il frutto di un “automatismo” processuale oggettivo, come nei casi sopra passati in rassegna, ma, piuttosto, il risultato di un ribaltamento integrale dell’originario quadro indiziario e cautelare, cui il giudice procedente è pervenuto, nell’esercizio della sua discrezionalità valutativa, in base al compendio probatorio acquisito, e che lo ha indotto, con la decisione assolutoria, a travolgere dalle fondamenta la misura coercitiva già applicata”.
Partendo dal dato superiormente esposto, è possibile affermare – secondo le Sezioni Unite – che il provvedimento cautelare, emesso (ex art. 300, comma 5, c.p.p.) successivamente alla sentenza di condanna in grado di appello per lo stesso fatto, è da considerarsi dotato del carattere della “novità” e della “autonomia”.
Difatti, la nuova misura disposta – una volta emessa la sentenza di condanna in appello – è il frutto di un nuovo giudizio di cognizione “arricchito da nuove prove, sicché difficilmente può dubitarsi della sua autonomia rispetto al primo provvedimento caducato in conseguenza dell’assoluzione”.
Inoltre, devesi rammentare che la norma contenuta nell’art. 275 c.p.p. “impone al giudice, contestualmente alla pronuncia di una sentenza di condanna, un particolare esame delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen., lett. b) e c), da apprezzare alla luce dell’esito del procedimento, della sanzione applicata, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, al fine di stabilire se, a seguito della decisione di condanna, si renda necessaria l’adozione di una misura cautelare personale”.
Il secondo comma della predetta norma, invece, si occupa del caso in cui l’applicazione della misura cautelare debba essere disposta – in caso di condanna in appello – per uno dei reati di cui all’art. 380 c.p.p. che siano stati commessi da soggetto recidivo. In casi consimili, difatti, l’obbligatorietà dell’adozione della misura si fonda sulla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p..
Per dirimere ogni dubbio di sorta è risultato risolutivo l’intervento, in plurime occasioni, della Corte di Cassazione che “ha posto in evidenza la diversa portata delle due disposizioni: la prima, come è reso palese anche dal chiaro e univoco tenore letterale, impone al giudice che pronunci una sentenza di condanna una valutazione discrezionale, in base a parametri predefiniti, della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen.; la seconda stabilisce l’obbligo per il giudice di appello, quando l’anzidetta valutazione si risolva nell’accertamento della sussistenza delle esigenze cautelari, di adottare la misura nei casi in precedenza indicati di condanna per uno dei reati elencati nell’art. 380, comma 1, cod. proc. pen., commessi da soggetto recidivo” (cfr. Sez. 1, n. 4746 del 13/01/2011, Lecini, Rv. 249793 – 01; Sez. 1, n. 43814 del 08/10/2008, Sutera, Rv. 241558 – 01; Sez. 1, n. 30298 del 24/04/2003, Privitera, Rv. 226250 – 01; Sez. 4, n. 28094 del 12/06/2002, Del Vecchio e altro, Rv. 222130 – 01).
Il dato superiormente esposto assume decisivo rilievo poiché, salvo i casi di cui all’art. 275, comma
2-ter, c.p.p. (obbligatorietà da parte del giudice di adozione della misura) – “rimane comunque salva la facoltà del giudice d’appello di valutare discrezionalmente la necessita o meno della misura, non diversamente da quanto può fare il giudice di primo grado”.
Ciò posto, le Sezioni Unite hanno evidenziato come nei tre diversi casi dianzi indicati (art. 300, comma 5, e art. 275, commi 1-bis e 2-ter, cod. proc. pen.) emerga un dato di assoluta importanza ossia l’obbligo del giudice di procedere alla rivalutazione delle esigenze di cui all’art. 274 lett. b) e c) c.p.p. “attraverso un accertamento compiuto alla luce dei fatti emersi nel processo, anche di secondo grado”. Tale accertamento “contiene, evidentemente, una componente di “novità”, in quanto viene effettuato su basi diverse rispetto a quelle oggetto di verifica operata in sede di emissione della ordinanza genetica, tenuto conto che è trascorso del tempo e, intanto, è intervenuta la sentenza di condanna di secondo grado”.
Il Supremo Collegio ha inoltre rilevato come sia totalmente irragionevole ipotizzare una “differenziazione” nella esperibilità del mezzo di impugnazione (riesame o appello) tra l’imputato condannato in appello e destinatario di un provvedimento coercitivo (il quale non sia mai stato raggiunto da precedente titolo cautelare o dopo essere stato destinatario di titolo cautelare poi annullato o revocato nel corrispondente subprocedimento cautelare) e l’imputato che, dopo essere stato prosciolto in primo grado, venga condannato in appello e successivamente attinto da misura cautelare a seguito della emissione da parte del giudice competente del relativo provvedimento limitativo della libertà personale.
Difatti, “la proposizione del riesame per il primo ambito e dell’appello per il secondo non rinverrebbe idonea giustificazione – secondo la convincente obiezione sollevata dalla dottrina – nella differenza di situazioni di fatto, a fronte della omologia della valutazione dei presupposti di emissione di un’ulteriore misura nei confronti di ognuno dei destinatari della stessa”.
Pertanto, secondo le Sezioni Unite, l’ordinanza emessa ai sensi della norma contenuta nell’art. 300, comma 5, c.p.p. non può essere considerata quale mera “reviviscenza” dell’ordinanza genetica (successivamente oggetto di caducazione) dal momento che il quadro cautelare può essere fortemente mutato alla luce del “trascorrere del tempo e [dell’] intervento della sentenza di condanna in appello, che ha ribaltato la decisione di proscioglimento adottata in primo grado: il provvedimento de quo, viceversa, presenta indubbi aspetti di “novità” ed “autonomia” in confronto a quello precedente, sì da giustificare, per la sua impugnazione, l’attivazione del procedimento di riesame”.
Tale ragionamento si fonda su alcuni elementi essenziali:
- “il carattere di forte cesura impresso alla primigenia vicenda cautelare dalla sentenza di assoluzione emessa in primo grado, in coerenza con la già ricordata ratio giustificatrice della introduzione della norma in commento”;
- “la componente di “novità” intrinseca nel giudizio di appello e nella condanna che ribalti la pronuncia assolutoria, essendo rimesso al giudice di secondo grado, anche in assenza di rinnovazione istruttoria dibattimentale, il compito di “rivalutare” le esigenze cautelari mediante un accertamento compiuto alla stregua dei fatti emersi nel processo, anche sopravvenuti, e necessariamente effettuato su basi diverse rispetto a quelle oggetto di verifica operata in sede di emissione della ordinanza genetica, poi venuta meno”;
- “l’omologia dei criteri valutativi e delle regole che il giudice emittente l’ordinanza di cui all’art. 300, comma 5, cod. proc. pen. è tenuto ad applicare rispetto ai criteri e alle regole imposti al giudice emittente la misura cautelare nei casi previsti dall’art. 275, commi 1-bis e 2-ter, cod. proc. pen., con riferimento ai quali la giurisprudenza di legittimità ha affermato la praticabilità del ricorso con istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.”;
- “l’esigenza di evitare irragionevoli discriminazioni, nell’opzione dello strumento di tutela, tra medesime situazioni di fatto”.
Sulla scorta di tali considerazioni è stato, pertanto, enucleato il principio di diritto secondo cui: “Nel caso in cui l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, venga successivamente sottoposto, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., a nuova applicazione della custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell‘istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.”.
Cass. Pen., Sez. U, Sentenza n. 44060 (11.07.2024 Ud.), deposito del 03 dicembre 2024
potrebbero interessarti…
Gli approfondimenti…
News dalle Sezioni Unite
…entra

Iscrivendoti alla nostra Newsletter acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Concessione del consenso per ricevere esclusivamente approfondimenti di interesse giuridico. Per ulteriori informazioni, clicca qui