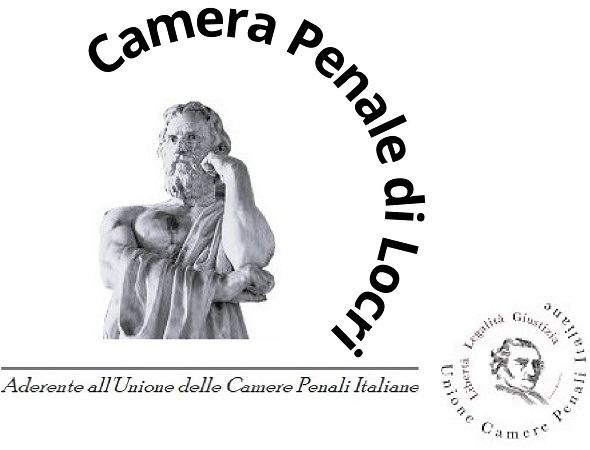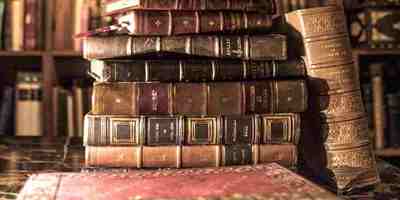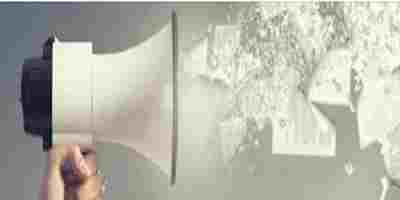In tema di ordinamento penitenziario, le modifiche legislative successive ai fatti per i quali è intervenuta condanna che rendano più gravoso l’accesso alle misure alternative alla detenzione ed ai benefici penitenziari “extra moenia”, assoggettando il condannato ad un trattamento più severo di quello che era ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del reato, non possono avere applicazione retroattiva, alla luce della lettura dell’art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020. (Fattispecie relativa a istanza di ammissione alla semilibertà presentata da detenuto per fatti commessi nel vigore delle disposizioni introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nella quale la Corte ha ritenuto inapplicabili le successive modifiche legislative, in concreto deteriori in relazione alla situazione individuale dell’istante).
A cura di Giuseppe Calderazzo (Avvocato del foro di Locri e vice-presidente della Camera Penale di Locri)
- Il Tribunale di sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile l’istanza di ammissione alla semilibertà presentata dal condannato, detenuto dal 24 ottobre 1991, per reati previsti dalla prima fascia dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario. In particolare, si legge nell’ordinanza che il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 20 dicembre 2022, n. 199 dovesse considerarsi di maggior favore rispetto a quella già applicata al condannato perché avrebbe fatto venir meno il carattere ostativo del titolo della condanna, eliminando la preclusione assoluta per i condannati per reati di cui all’art. 4-bis Ord. pen. “prima fascia”. Secondo il Tribunale, infatti, la recente riforma non ha rappresentato un quadro normativo sfavorevole rispetto ai precedenti, e così – in forza del principio del tempus regit actum – ha ritenuto che il condannato dovesse rispettare i nuovi oneri di allegazione attualmente previsti dall’art. 4-bis Ord. pen., ovvero il dover allegare elementi comprovanti l’adempimento delle obbligazioni civili o l’impossibilità di adempiervi, nonché́ elementi diversi dalla regolare condotta carceraria da cui fosse possibile evincere l’insussistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo del loro ripristino.
- Il ricorso del condannato che censurava gli artt. 48 e 50 dell’ordinamento penitenziario è stato ritenuto fondato dalla Suprema Corte che, muovendo dalla evoluzione della giurisprudenza in tema di applicabilità delle restrizioni previste dall’art. 4 bis O.P. alle esecuzioni in corso al momento della sua entrata in vigore, è giunta alla conclusione che le modifiche legislative successive ai fatti per i quali è intervenuta condanna che rendano più gravoso l’accesso alle misure alternative alla detenzione, assoggettando il condannato a un trattamento più severo di quello che era ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del reato, non possono avere applicazione retroattiva, alla luce della lettura dell’art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020.
In particolare la Corte ha evidenziato che sin dall’introduzione dell’art. 4-bis Ord. pen. la giurisprudenza era concorde nel ritenere l’applicabilità delle preclusioni e delle restrizioni previste dalla norma alle esecuzioni in corso, al momento della sua entrata in vigore, per i fatti anteriormente giudicati o commessi. L’indirizzo interpretativo è rimasto conforme anche a seguito dell’ampliamento delle fattispecie indicate nell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. È stato affermato, infatti, che le disposizioni legislative, le quali individuano i delitti ostativi ai benefici penitenziari o stabiliscono peggioramenti della disciplina di accesso ai medesimi, sono relative alle modalità di esecuzione della pena e trovano immediata applicazione anche per i fatti e le condanne pregresse. Ciò̀ in mancanza di una specifica regolamentazione transitoria che risulta assente anche nel caso in esame, facendo leva sulla natura processuale delle disposizioni relative all’Ordinamento penitenziario, oltre che sull’applicazione del criterio risolutore offerto dal principio tempus regit actum.
2.1 L’impostazione sinora descritta è stata rimeditata già con Sez. 1, n. 17203 del 28/02/2020, PG C/Posocco, Rv. 279215, anche alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 32 del 2020 emessa in relazione alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, con la quale è stata elaborata in materia di esecuzione della pena una lettura diversa della portata del divieto di retroattività di cui all’art. 25, comma secondo, Cost.
Il Giudice delle leggi ha, infatti, specificato che quando la normativa sopravvenuta non incide sulla modifica delle modalità̀ esecutive della pena, prevista dalla legge al momento del reato, ma ne opera una vera trasformazione che ha effetti sulla libertà personale del condannato, non è possibile derogare ai principi espressi dall’art. 25, comma secondo, Cost.
Il diverso statuto, delineatosi per effetto della successione normativa, in questi casi, se non applicato ai soli fatti di reato posteriori, determina un trattamento che sostanzialmente si risolve in un trattamento deteriore rispetto a quello legalmente stabilito al momento della violazione, con mortificazione delle garanzie che sono alla base del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano la pena prevista per il reato.
La valutazione va operata, in generale, in chiave di prognosi, comparando, rispetto al tempus commissi delicti, la pena che era ragionevole attendersi in base alla legislazione vigente e quella che potrebbe derivare in concreto per il detenuto per effetto del mutato quadro normativo.
La trasformazione di maggiore afflittività sussiste quando il condannato può essere assoggettato a un trattamento “più severo” rispetto a quello che era ragionevolmente prevedibile nel momento di commissione del reato. Ciò anche avuto riguardo, sia pur in termini probabilistici, all’accesso a modalità extra- murarie di esecuzione della pena, quali quelle previste dalle misure alternative alla detenzione o da altri benefici penitenziari.
La Corte costituzionale ha, infatti, chiaramente affermato che questi ultimi, ove consentano di uscire dal carcere, sono misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena. Esse, dunque, incidono sul grado di privazione della libertà personale e costituiscono “pene alternative” alla detenzione caratterizzandosi per ridurre la limitazione alla libertà personale del condannato e per offrire opportunità rieducative molto diverse da quelle che caratterizzano la pena detentiva intra-moenia in senso stretto.
Per queste ragioni le novelle al testo normativo di cui all’art. 4-bis Ord. pen. per l’accesso alle misure alternative alla detenzione e le limitazioni ai benefici penitenziari che consentono di ridurre i tempi di permanenza in carcerazione debbano essere valutate in concreto rispetto alla particolare situazione individuale del detenuto in relazione alla data di commissione del reato per cui è stata disposta la condanna e la conseguente carcerazione. In particolare, le modifiche normative non possono operare retroattivamente, estendendosi a fatti commessi prima dell’entrata in vigore delle relative modifiche che rendono più gravoso l’accesso alle misure alternative alla detenzione e ai benefici penitenziari extra-moenia, tenuto conto che, in materia di successione di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole con riferimento al caso concreto, il giudice deve applicarla nella sua interezza, essendo fatto divieto, in ossequio al principio di legalità, di combinare frammenti normativi dell’una e dell’altra, così da delineare una terza disciplina (Sez. 4, n. 13207 del 27/01/2022, Premoli, Rv. 282936).
- Nel caso in esame, con le modifiche apportate all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per effetto dell’entrata in vigore del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199, diversamente da quanto affermato dal provvedimento impugnato senza dimostrazione alcuna, si sono peggiorate le condizioni per l’accesso e la fruizione della semilibertà richiesta dal ricorrente. Egli, infatti, risulta essere detenuto dal 24 ottobre 1991 per fatti ricondotti 416-bis cod. pen. compiuti sino e non oltre quella data, come affermato dal Tribunale sulla base della lettura delle sentenze di condanna.
Secondo il testo dell’art. 4-bis ord. pen. in vigore nel 1991 (versione di cui al d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla I. 12 luglio 1991, n. 203) per accedere alla semilibertà era sufficiente acquisire solo elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti dell’istante con la criminalità organizzata o eversiva, limitandosi a richiedere tali informazioni “per il tramite del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato”. Attualmente, la nuova normativa intervenuta con il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, poi convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, ha apportato modifiche alla disciplina prevista dall’art. 4-bis legge n. 354 del 1975 (Ord. pen.), ravvisando i presupposti di straordinaria necessità e nei «moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore per l’adozione di una nuova regolamentazione dell’istituto al fine di ricondurlo a conformità con la Costituzione». Ha così inciso proprio sulle disposizioni sottoposte a scrutinio di costituzionalità, specificamente sostituendo integralmente il comma 1-bis dell’art. 4-bis Ord. pen., a cui ha pure aggiunto due nuovi commi (1-bis.1 e 1-bis.2). La novità principale della nuova disciplina è stata rinvenuta nella trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti. Costoro, infatti, sono ora ammessi alla possibilità di proporre richiesta, che può essere accolta in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati per i quali è intervenuta condanna.
Tra i reati per cui il ricorrente è stato condannato, senza poi aver collaborato con la giustizia, vi è l’art. 416-bis cod. pen. il quale rientra nel catalogo dei reati di cui all’art. 4-bis, commi 1 (richiamati dal comma 1-bis), Ord. pen., in relazione al quale oggi, in virtù della novella già citata, si è previsto che, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ai detenuti possono essere concessi i benefici penitenziari a condizione che: – dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di adempimento; – alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso,, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile; – il giudice accerti la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
Come correttamente evidenziato in ricorso, la differenza tra le due discipline, nel senso che la precedente fosse chiaramente di maggior favore, è evidente, non solo sul tema dell’introdotto adempimento delle obbligazioni civili che è chiaramente gravosa per un soggetto detenuto da 32 anni, ma anche per gli altri elementi che caratterizzano sia gli oneri di allegazione dell’istante che l’istruttoria da svolgere ed è tale da influire in maniera evidente sulla possibilità di ritorno in libertà del ricorrente. A ciò va aggiunto che la novella legislativa ha inciso in modo fortemente deteriore sulla prospettiva del condannato di essere ammesso ad espiare la pena al di fuori del circuito carcerario rispetto a quanto disposto dalla legge in vigore al momento del fatto per cui è stato condannato.
L’entrata in vigore del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199, ha conseguito un effetto di trasformazione della pena inflitta, realizzando una concreta incidenza sulla libertà personale, rispetto al quadro normativo vigente al momento di commissione del fatto da parte del ricorrente. Da tali considerazioni deriva l’inapplicabilità̀ della nuova disposizione e di quelle precedenti pur successive a quella sinora ritenuta applicabile (versione di cui al d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla I. 12 luglio 1991, n. 203) al ricorrente dal Tribunale di sorveglianza in relazione a precedenti istanze di cui agli art. 21 e 30 Ord. pen., ai sensi dell’art. 25, comma secondo, Cost., trattandosi di condanna per reati commessi anteriormente all’entrata in vigore delle successive novelle legislative da ritenersi di maggior sfavore in relazione alla sua concreta condizione di detenzione.
I principi di cui alla sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2020 devono, pertanto, trovare applicazione anche nel caso in esame dovendosi richiamare un concetto “sostanziale” anche nell’esecuzione della pena, rispetto al procedimento interpretativo della modifica normativa, in difetto di una disciplina transitoria.
Il concetto di legalità della pena, dunque, si estende e comprende non la sola pena in astratto prevista per il fatto all’epoca in cui esso è stato commesso, ma anche quella che “in concreto” viene posta in esecuzione con modalità che incidono direttamente sulla libertà personale non solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna bensì anche nel corso della sua espiazione.
Cassazione penale sez. 1 n. 30702 del 16/04/2024 (dep. 26/07/2024)
potrebbero interessarti…
Gli approfondimenti…
News dalle Sezioni Unite
…entra

Iscrivendoti alla nostra Newsletter acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Concessione del consenso per ricevere esclusivamente approfondimenti di interesse giuridico. Per ulteriori informazioni, clicca qui