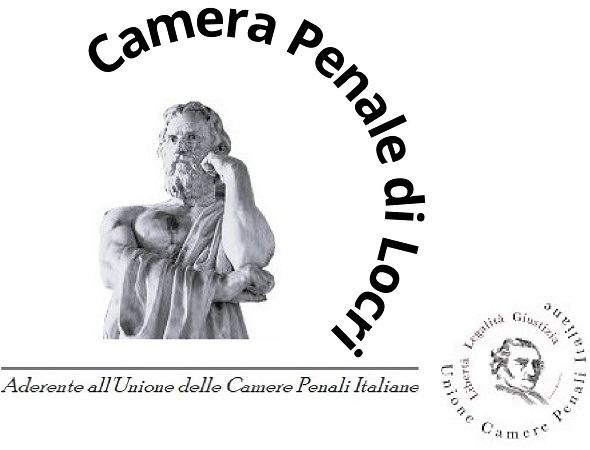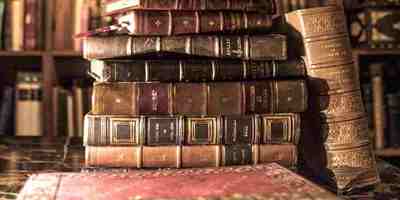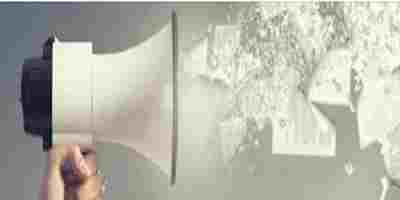Il preoccupante e crescente fenomeno dell’errore giudiziario, esplorato con l’esperienza professionale, accademica e politica dell’amico Nico D’Ascola, che ci ha fatto gradito omaggio del suo scritto, inducono a serie riflessioni su tale fenomeno e necessariamente alle molteplici cause che lo generano: una giustizia sempre più creativa che vanifica la norma esistente e che diventa diritto vivente; un Legislatore che insegue il populismo giustizialista di una società, che manifesta il suo malessere, reclamando una giustizia vendicativa; il circo mediatico che individua e crea il colpevole prima ancora di un giudizio, il tutto in una cornice di decadimento culturale complessivo di tutti gli attori che gravitano nell’ambito giurisdizionale proteso all’efficientismo, a scapito della qualità, che si ottiene soltanto con il rispetto dei principi costituzionali del giusto processo.
Grazie Nico per farci respirare quell’anelito di umanità che inspirò nel 1961 i grandi giuristi sull’Isola di San Giorgio a Venezia nella fondazione Cini ad affrontare, per come ha detto Francesco Petrelli “…le stesse criticità relative al processo e per cercare di porre rimedio alle problematiche nuove provocate dal progresso e dalla tecnologia ma anche dalla giurisprudenza creativa e dalle cattive abitudini.” (Antonio Alvaro)
1. I fondamenti sociali dell’errore giudiziario.
2. L’eterogenesi dei fini.
3. La morte del diritto.
4. La giustizia come azienda.
5. Il circo mediatico.
6. L’interpretazione creativa.
7. conclusioni.
* Questo articolo è dedicato alla memoria di Aldo e Mario Casalinuovo.
** Il presente articolo costituisce la elaborazione di una mia risalente prefazione a un libro (dedicato alla medesima questione) scritto dal Prof. Vincenzo Mastronardi, noto psichiatra forense dell’Università di Roma La Sapienza.
–/–
a cura di Nico D’ascola – Penalista e professore ordinario di Diritto Penale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria
1. I fondamenti sociali dell’errore giudiziario
Per un avvocato penalista quale io sono, scrivere dell’errore giudiziario è un compito difficile e sofferto. Tanto quanto è difficile scrivere delle cose che ti hanno tormentato per troppo tempo. Che l’esito di un processo avrebbe potuto (convinzione già sufficiente a generare il disagio) e, in taluni casi, dovuto esser diverso, è una sensazione talmente inaccettabile da indurre istintivamente meccanismi di rimozione.
Sul punto occorre preliminarmente osservare che le occasioni di errori giudiziari si moltiplicano in una società che con indifferenza sembra avere accettato l’idea che l’eterno conflitto tra libertà e autorità debba essere risolto nella preconcetta direzione di un buio trionfo della punizione. Esito scontato per società tecnocratiche e piatte, volte all’efficientismo e alla superficialità, indifferenti verso vicende individuali delle quali ritengono di non doversi troppo occupare. Ciò conferma che quelle efficientiste e tecnocratiche sono società per le quali l’imputato non è un uomo, ma solo un costo, un fastidioso caso di devianza da rimuovere al più presto. Talvolta anche indipendentemente dalla sua effettiva responsabilità. Con la conseguenza che l’errore giudiziario finisce per essere anche causato da accertamenti frettolosi.
Come tali ad alto tasso di errore. Nel medesimo quadro deve poi collocarsi la tendenza alle pene esemplari, quindi richieste e irrogate in violazione dei principi costituzionali di proporzione e di personalità colpevole della responsabilità penale. Tendenze per confermare la diffusione delle quali già basterebbe leggere alcuni programmi politici per la giustizia penale, sul punto orientati da sondaggi che ne dimostrano la popolarità. Senza poi trascurare che addirittura la nascita e l’iniziale successo di taluni partiti politici sono stati agevolati dalla diffusione di ottuse propagande giustizialiste, con estrema leggerezza condivise da larghi strati della nostra società. È chiaro che in un contesto siffatto il rischio dell’errore giudiziario esplode per effetto della spinta sociale alla punizione e della connessa svalutazione del significato da attribuirsi alla libertà e alla vita dell’uomo. Di quanto scrivo è sintomo l’agghiacciante numero di suicidi in carcere, che non sembra turbare più di tanto la coscienza nazionale, in tante altre disparate occasioni pronta ad esibire la propria sensibilità. In altri termini, la deriva anti-garantista innescata da mani pulite e la sete di protagonismo e carrierismo giudiziario che ne è derivata, hanno provocato una sorta di generalizzato consenso sociale a favore della condanna. Una sorta di surrettizio e improprio mandato popolare alla magistratura che di tale mandato è priva per legge. Consenso che però seduce i più fragili e inesperti. Insomma, sono ormai evidenti i fondamenti anche sociali e collettivi dell’errore giudiziario.
Ecco perché oggi appare inadeguata la sua tradizionale e ragionevole difesa, secondo la quale esso sarebbe causato da fattori esclusivamente concernenti la controversa interpretazione e applicazione del diritto, ovvero casi di difficile ricostruzione del fatto, risultando per tali ragioni inevitabile. Se è vero che esso è insito nella ingenua pretesa (tuttavia non altrimenti ovviabile) di ricostruire la verità attraverso attività processuali formalizzate e come tali non sempre in grado di garantire che ciò che si è acquisito corrisponda al vero, è altrettanto indiscutibile che una società veramente giusta dovrebbe limitare quanto più possibile il sacrificio dell’innocente.
Non si può poi ignorare che, nella condivisibile direzione di un significativo allargamento della nozione di errore giudiziario soccorre il pensiero di due grandi e veri maestri. Salvatore Satta, richiamando Francesco Carnelutti, ne sosteneva la diffusione. Anche una sentenza assolutoria in primo grado già ne proverebbe la esistenza. Mi permetto di aggiungere che a conclusioni analoghe si dovrebbe arrivare per il caso di un processo penale che non avrebbe dovuto celebrarsi nemmeno nella fase della udienza preliminare, per indagini che non avrebbero dovuto essere compiute, per misure cautelari che non avrebbero dovuto essere adottate o mantenute. Né si può escludere da questo stesso ambito una erronea e più grave qualificazione giuridica.
Casi, questi, anch’essi sintomatici dell’errore giudiziario. In altri termini la categoria della quale ci stiamo occupando, ben al di là di quanto taluni suggeriscono nel tentativo di minimizzare il fenomeno, non richiede la pronuncia di una sentenza di condanna successivamente corretta. In verità non vi è alcuna ragione per escludere che pure l’utilizzazione di un elemento di prova non adeguatamente verificato, ma presentato come grave, costituisca errore giudiziario, dato il contrasto, in casi siffatti, con il principio secondo il quale non è prova ciò che non è verificato o non è verificabile.
2. L’eterogenesi dei fini
Il clima che ho tratteggiato ha fortemente eroso la cultura del dubbio, nonché del rigoroso rispetto delle garanzie processuali. Ma soprattutto dei principi fondamentali, anche di quelli costituzionali sui quali molti, compresi quelli che se ne discostano, hanno pure dovuto giurare. Ne è conseguita la sconfitta del progetto di matrice popperiana di una verità non assoluta e non imposta dall’alto. Bensì frutto di verificazione e falsificazione. La convinzione che nel processo penale non si ponga una questione di verità in termini assoluti, ma che la sentenza stessa si accrediti soltanto nel caso in cui le attività che l’hanno generata abbiano compiuto un percorso dialetticamente qualificato, non ha trionfato. Ciò malgrado le scienze superiori abbiano da tempo insegnato che non tutte le proposizioni vere sono dimostrabili come tali e addirittura che il risultato dell’esperimento scientifico muta a seconda dello sperimentatore. Enunciati, questi, sufficienti a scolpire i lineamenti di una scienza che con ammirevole modestia esibisce la propria incertezza, al contrario di quanto sembra avvenire altrove. Incertezza che, trasferita al processo penale, se anche non può limitare ad libitum la pronuncia del giudice, andrebbe tenuta in maggior conto. Analogamente deve dirsi con riferimento alla saggia e pacata convinzione secondo la quale giudicare è attività estremamente difficile e complessa, che implica, non soltanto il superamento di un concorso, ma, altresì, cultura generale e cultura giuridica (oggi poco diffuse, dato anche il pietoso stato della istruzione e della cultura, recentemente confermato dal tardivo allarme dell’OCSE), nonché intelligenza, esperienza, buon senso, equilibrio e un pizzico di conoscenza della vita. In altri termini formazione umana e – mi permetto di aggiungere, richiamando sul punto Leonardo Sciascia – una salda coscienza democratica, da porre alla base dell’uso di poteri così devastanti. Quindi rispetto per il prossimo, posto che il diritto penale non può diventare il diritto penale del nemico. La giustizia penale può (e se ne ricorrono i presupposti deve) essere severa, ma non può mai assumere sembianze persecutorie. Anche questa volta, in modo del tutto opposto la legge consente che i collegi giudicanti siano composti da magistrati giovanissimi, certamente animati dai migliori propositi, ma non per loro colpa in debito di esperienza e maturità professionale. Taluni tra costoro sono dotati di eccezionali capacità. Ma non tutti possono risultare tali, dal momento che le regole imposte alle umane capacità valgono per ogni categoria. Circostanza, questa, che rende evidente il ruolo benefico svolto dalla esperienza e dalla maggiore conoscenza acquisita attraverso il prolungato esercizio delle attività giurisdizionali. Collegi (ovvero giudici monocratici) dotati però di una competenza che si spinge sino ai massimi edittali. Giusto per paragonare il presente (non sempre migliorativo) al passato, occorre ricordare che, un tempo, anche per ovviare a questi stessi problemi, chiaramente percepiti da quel legislatore, erano state istituite le Preture. Preture poi eliminate dalla organizzazione giudiziaria per ragioni del tutto condivisibili e note ma che, occorre ammetterlo, costituivano vere e proprie scuole di formazione per i giovani magistrati ai quali era attribuita una limitatissima competenza per reati puniti sino a tre anni. Insomma, la capacità di giudicare rendendo giustizia è per pochi. Sul piano poi del sistema processuale deve tristemente osservarsi che, al contrario delle più legittime aspettative il vecchio di peggior fattura si è travestito di nuovo ed ha vinto la sua battaglia. Tanto che molti si stupiscono di rimpiangere il codice fascista.
Stupisce anche il fatto che, malgrado gli sforzi divulgativi e le sfavillanti analisi di Luigi Ferrajoli sul garantismo, oggi sono ancora in molti a non averne compreso il senso. Nemmeno quello più facilmente afferrabile, ossia garantismo come timido e inidoneo tentativo di riequilibrare l’enorme divario tra le risorse e i mezzi che lo Stato impiega nelle indagini e gli strumenti dei quali, tra l’altro molto tardivamente rispetto al loro inizio, può disporre l’imputato. Sul punto è chiaro che tutti devono comprendere le esigenze delle indagini preliminari che nella maggior parte dei casi è necessario rimangano segrete, pena la loro inutilità. Ma ciò altro non fa che confermare l’obbligo delle garanzie da un lato, e la struttura inevitabilmente squilibrata del processo penale dall’altro. Squilibri, però, che dovrebbero indurre moderazione nel corso del giudizio.
Ecco perché oggi si potrebbe semmai obiettare che dell’errore giudiziario siamo tutti responsabili o – per meglio dire – che di questo è pure responsabile l’attuale livello di una società feroce ed estremista. D’altronde non è quello del sistema giustizia l’unico settore delle moderne società occidentali, del tutto sopravvalutate, dal quale emergono tendenze oscure e irrazionali che i più ingenui, sempre inclini all’ottimismo, avevano ritenuto definitivamente scomparse. Al punto che oggi, anche nella civilissima Europa, non apparirebbe insensato un richiamo alla società dei lumi o un ritorno allo studio dei classici e ai valori dell’umanesimo. Né si può pensare che il giudice e il pubblico ministero, in quanto uomini e donne di questa società, non siano condizionati dal clima nel quale vivono e dalla pubblica opinione. Non può nemmeno escludersi che di questa taluni siano indotti a cercare il consenso. Insomma, nella tensione dialettica tra conformismo burocratico ed eroismo intellettuale, è alto il rischio che il primo prevalga sul secondo.
3. La morte del diritto
Tutto ciò premesso, a me sembra che il diritto mite, a suo tempo tanto pubblicizzato, sia morto, o che forse non sia mai nato, essendo rimasto un sogno o peggio uno slogan. Questo stesso clima genera le cause che ostacolano il successo di quella prevalente parte della giustizia nazionale realmente colta, problematica e intellettualizzata, davvero preoccupata dell’individuo e delle garanzie che dovrebbero circondarlo, sempre attenta a non cadere in errore.
Esattamente al contrario, taluni addirittura si vantano dell’idea secondo la quale non esisterebbero imputati innocenti, essendo gli assolti soltanto dei furbi che si sono abilmente sottratti al giusto castigo. Italianamente agendo all’opposto, però, quando devono tutelare sé stessi. L’essersi avvalsi della facoltà di non rispondere, ossia l’esercizio di un diritto, è divenuto indizio di colpevolezza. Parole gravissime, perché eversive dei principi costituzionali. Parole che un tempo nessuno avrebbe pensato di dover sentire o leggere, perché manifestamente contrarie, non solo alla lettera, ma anche allo spirito della nostra Costituzione repubblicana. Parole, però, che malgrado tutto quanto osservato sono entrate nel vocabolario e nel dibattito giuridico, addirittura pretendendo rispetto e peggio ancora riscuotendo successo. Segno evidente di un grave crepuscolo delle conoscenze. Crepuscolo che offusca il diritto, sino a renderlo superfluo. In altri termini il diritto, quello vero, sarebbe un lusso che non potremmo più permetterci. Ma se le cose stanno davvero così non può escludersi che il mondo del diritto di stampo europeo e liberale possa frantumarsi da un momento all’altro. Tanto per esemplificare, il recente ridimensionamento della oralità conferma i sospetti di cui sopra. Sul punto noi avvocati siamo sembrati come colti di sorpresa, o forse rassegnati in attesa di ulteriori e più gravi tracolli. Retoricamente mi domando quale sarebbe stata la reazione del pur moderato Chiovenda, se posto dinanzi a una oralità da autorizzare.
4. La giustizia come azienda
Ognuno comprende che più si spinge la giustizia verso orizzonti aziendalistici e progetti efficientisti, più l’imputato e la sua vicenda umana appaiono inezie da rimuovere sulla via di una punizione (probabilmente in buona fede) ritenuta senza serie alternative sin dall’inizio delle indagini preliminari. Lo stesso giudizio penale è visto, quindi, come un costo insopportabile, anziché come il luogo dove occorre accertare la reale responsabilità dell’imputato. Di questa diffusa forma di miopia e insensibilità, costituisce conferma la recente soppressione del Tribunale per i minorenni (soppressione che, a suo tempo, io ero riuscito a impedire). La scelta legislativa di cui ci stiamo occupando è gravissima e rischia di produrre effetti devastanti sul terreno della criminalità giovanile e quindi del pericolo di perduranti carriere criminali. Né può tacersi la sottovalutazione del fondamentale ruolo svolto da magistrati specializzati, esclusivamente versati in un settore del tutto peculiare perché contrassegnato da prospettive, esigenze e programmi del tutto diversi rispetto a quelli del processo ordinario (rigorosamente rispettati dal legislatore del 1930, nonché da quello del 1988). Sottolineati anche dalla presenza nel collegio di soggetti dotati di competenze scientifiche in grado di rendere la pronuncia del giudice effettivamente calibrata, non solo sul fatto, ma anche su di una personalità in fase di delicata formazione. Del tutto al contrario, chi giudicherà non sarà più dotato di una specifica competenza, non godrà dei vantaggi della collegialità, né della presenza di esperti. Si dovrà occupare di tutto ciò che compete al neoistituito Tribunale della famiglia, cui faranno capo anche vicende civilistiche, avendo peraltro anche l’obbligo di comporre sia il Tribunale circondariale, sia la Corte d’appello. È chiaro che tutto ciò non potrà che incentivare errori in un settore delicatissimo. Né può trascurarsi il connesso tema dell’eccesso del carico giudiziario. Tema trattato in uno spazio intermedio tra il tentativo di trovarsi un alibi e la disarmante inerzia dinanzi ad una realtà sapientemente presentata come ineluttabile. Della quale realtà non a caso nessuno, soprattutto chi ne parla, sarebbe responsabile. A proposito delle scelte legislative con le quali si è pensato di fronteggiare la questione penale, il più istruttivo libro di diritto penale (non ancora scritto), dovrebbe commentare le leggi di riforma del sistema. Leggi che si sono succedute dagli anni ’70 in avanti, al fine di illustrarne il senso e le finalità. Si scoprirebbe, così, una netta tendenza asistematica e autoritaria, monotonamente giustificata dall’immancabile alibi della casa che brucia e dalle altrettanto immancabili lodi all’eroico pompiere. Emergerebbero linee di politica legislativa costantemente restrittive delle libertà dei cittadini delle quali una certa politica e i suoi oscuri consiglieri sono pienamente responsabili. Per giunta, come in tutti i casi in cui non si riesce a intravedere un limite agli eccessi, taluno si lamenta ancora della inadeguatezza del sistema punitivo. È così che il diritto penale, che dovrebbe ispirarsi al principio di frammentarietà, proprio a partire dai decisivi anni ’70 è divenuto, al contrario, totale. Punisce tutto ed ambisce ad espandersi ancora, fino a divenire l’unica forma di illecito. È ovvio, pertanto, che a un diritto penale divenuto quantitativamente enorme e per di più sbilanciato nell’uso di tecniche legislative anticipatrici della punizione, scarsamente consapevoli del principio costituzionale di offensività, quindi ulteriormente dilatative della matière penale, debba corrispondere una enorme quantità di processi. Quando poi si propongono soluzioni forti, ma davvero efficaci, come il ritorno alle regole del sistema penale, la facoltatività guidata dell’azione penale, la patteggiabilità di ogni pena (sia pure con limiti legislativi), chi prima si stracciava le vesti gridando alla sempre invocata casa che brucia, muta atteggiamento. Divenendo subito cauto, solennemente afferma che con qualche ennesima (e inefficace) alchimia processuale, tutto sommato si può proseguire sulla stessa strada. Ma non basta. Nemmeno si riflette sullo status intellettuale e sulla affidabilità del giudice efficientista che si vorrebbe, inevitabilmente retrocesso a burocrate da intellettuale che era. Così avallando anche la convinzione secondo la quale la giurisdizione non dovrebbe preoccuparsi dei vincoli posti dalla dogmatica, divenendo così più agile e spedita. Accademia e avvocatura, di conseguenza, non rivestirebbero un ruolo effettivo all’interno della giurisdizione, esclusivamente attribuita a una magistratura pratica e spiccia. Non vi sarebbe spazio neppure per quei tradizionali suggerimenti critici finalizzati a richiamare l’attenzione sui principi che reggono il sistema e a sollecitare il dibattito e l’evoluzione della giurisprudenza. Taluni, poi, orgogliosamente affermano, senza avvertire alcun imbarazzo, che le sentenze non si commentano. Ciò, malgrado il diritto sia da tempo immemorabile secolarizzato e le sentenze siano laicamente pronunciate in nome del popolo italiano. Siamo talmente arretrati da colorare di fas lo ius.
Giova osservare che questa immagine sacerdotale della magistratura è sbagliata e deformante, perché contraria alla realtà e al diritto, anche perché le attribuisce una indimostrabile infallibilità. Si può davvero pensare che tutto ciò non incida sui casi di errore giudiziario?
5. Il circo mediatico
Non a caso si discute di un attore che senza molta fatica si è fatto spazio nel processo penale, il pregiudizio. Sostantivo al quale aggiungerei l’ulteriore termine condizionamento. È fin troppo noto il fenomeno della spettacolarizzazione dei processi. I media (sospettati di oscuri legami con taluni magistrati), ma prima ancora le conferenze stampa e la fuga di notizie, già presentano gli imputati come sicuri colpevoli. Al punto che il processo sembra già concluso ancor prima di iniziare. La pubblica opinione finisce per convincersi della inutilità di un giudizio che, a quel punto, le sembra finanche dannoso, dato semmai il rischio di ribaltare una verità da tutti ormai condivisa. Risultato, se si pensa all’art. 111 della Costituzione e alla indiscutibile preminenza del giudizio rispetto alle indagini preliminari, del tutto capovolto e in aperta violazione dei principi del codice e costituzionali. A tal punto non si comprende come quel piccolo uomo vestito di nero (ossia l’avvocato) possa ribaltare un esito che tutti danno per scontato. Poi, nei casi in cui la Cassazione, nel rispetto dell’art. 65 dell’ordinamento giudiziario (a molti sconosciuto), riafferma il diritto oggettivo, taluni quotidiani addirittura si scandalizzano, e disseminano sospetti, non di rado equivalenti a calunnie. Il milieu che descrivo è pure arricchito dall’immancabile dubbio circa il ruolo e le iniziative del difensore, puntualmente bollate come dilatorie, se non addirittura dimostrative di connivenza. Difensore un tempo ritenuto paladino dei diritti. Ma oggi inascoltato da chi avrebbe cose più importanti da fare. Il passo successivo è costituito dalla strabiliante idea secondo la quale è la difesa penale alla quale bisognerebbe porre limiti. Esattamente al contrario di quanto accade in Italia, la figura del difensore, nei paesi davvero democratici, è molto forte e rispettata. Anche perché è ritenuto il soggetto che più di tutti conosce il tasso di effettiva democraticità del sistema punitivo (forse è per questa ragione che in Italia non è benvoluto). Ciò a riprova di come qui da noi il clima sia cambiato. Contro questa incivile deriva ho sentito parlare solo gli avvocati, e non tutti.
È pertanto chiaro che questo vento costituisce l’humus ideale dell’errore giudiziario in cui può cadere un giudice a questo punto divenuto anche marginale. Un giudice schiacciato da un titolare dell’accusa che ormai domina la scena, avendo acquisito una superiore credibilità sociale e maggiore popolarità.
6. L’interpretazione creativa
Se tutto questo non bastasse, a completare il quadro dell’errore giudiziario concorre l’interpretazione creativa. Consiste nel punire ciò che la legge penale non consentirebbe di punire. Circostanza, questa, che già la presenta come una invenzione sorprendente sì, ma nel senso della sua intollerabile stravaganza. Proposta da chi non è mai entrato in una aula di giustizia, guarda con aristocratico distacco all’incolto conservatore refrattario rispetto ad ogni evoluzione. Costui replica con affanno che la legge penale è di esclusiva competenza del Parlamento in virtù della rappresentanza popolare della quale solo quest’ultimo è investito. Che soltanto la legge penale, non la interpretazione, è obbligatoria. Che il giudice (ma anche il pubblico ministero) non può mutarne il contenuto, pena la violazione che il principio costituzionale del divieto di analogia sfavorevole. Che il cittadino può calibrare le proprie libere scelte d’azione con esclusivo riferimento al testo scritto della legge e che questi principi discendono, non da un atto sublegislativo o da personali convinzioni, ma dalla nostra stessa Costituzione (art. 25 cpv.). Costituzione che peraltro pretende, non solo la separazione dei poteri, ma anche la reciprocità dei controlli. Nonché l’autonomia e la indipendenza anche della politica (ad esclusiva tutela della funzione, non di chi ne è titolare). Quella tutela della politica, chiaramente finalizzata a garantire gli equilibri istituzionali, che si sono persi con la modifica dell’art. 68 Costituzione. Modifica che all’epoca non scatenò le polemiche che oggi circondano la proposta di separazione delle carriere dei magistrati. Ognuno però comprende che una legge penale dai contenuti cangianti e dal testo modificabile perché subordinato al contesto, fatta di opinioni personali e di visioni ideologiche spinte sino al limite di un riedito Volksgeist, finisca per punire ciò che il legislatore aveva ritenuto di non dover punire.
La stessa sociologia del diritto insegna che politica e magistratura sono sistemi separati che possono (e debbono) cooperare, ma che non possono contendersi competenze, soprattutto allorquando esse sono chiaramente distribuite. Sul punto, recentemente, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza. Non si può tuttavia negare che simili vicende ci consegnino un volto disomogeneo della magistratura su questioni però fondamentali. Disomogeneità che contribuisce ad alimentare una complessiva incertezza della società. Per quel che vale, ma soprattutto per evitare accuse di strabismo, nego pure che l’avvocatura versi in condizioni migliori.
Tornando alla magistratura, credo che questo andazzo ne danneggi l’autorevolezza, un tempo fuori discussione. La stessa immagine del pubblico ministero ne soffre. Pubblico ministero che talvolta appare schiavo di una opinione pubblica il consenso della quale può dare l’illusione di una investitura popolare di serie b. Consenso che però reclama una giustizia rapida nonché risultati certi, i quali, tuttavia, non possono essere garantiti. Così andando le cose si alimenta, ancora una volta, la falsa convinzione che il processo sia strumento di convalida – non di verifica – di una verità investigativa che non potrebbe revocarsi in dubbio.
Le cose vanno addirittura peggio nel caso in cui allo scenario sopra descritto si aggiunga la variante del maxi-processo. Ossia di centinaia di posizioni destinate ad essere valutate congiuntamente e in modo contratto, se non addirittura superficiale. La mancata o incompleta conoscenza degli atti, fenomeno già oggi preoccupante, nel caso dei maxi-giudizi rischia di esplodere.
Nella medesima direzione di un sistema giustizia senza una stella polare, si deve considerare anche il fenomeno dell’impoverimento strutturale, pure per via legislativa, delle fattispecie di reato. Caso emblematico di vicende nelle quali il legislatore ha già deciso che vi è poco da provare, così rendendo impossibile la difesa.
Che dire, infine, degli effetti delle già richiamate visioni ideologiche e personali trasferite al processo penale, della ingenua predilezione per l’idea soggettiva del giusto che induce taluni a trascurare la funzione intermediatrice del diritto e gli effetti benefici del contraddittorio e della oralità, principali antidoti all’errore giudiziario. In quest’ottica non può certo escludersi che la opinione politica del magistrato, se non tenuta ben distante dall’esercizio delle funzioni, possa agire da detonatore. Non è un caso che i magistrati di un tempo, non solo non la dichiaravano, ma fermamente evitavano che trasparisse. Ciò per la evidente ragione che ne sarebbe conseguita una perdita di imparzialità. Del tutto appropriatamente, di recente, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato che la imparzialità è requisito irrinunciabile della giurisdizione e che deve declinarsi, non soltanto sul piano dell’essere, ma anche su quello dell’apparire. Infatti, il magistrato che intende partecipare al conflitto sociale, magari decidendolo, non può poi pretendere il rispetto per l’esercizio delle sue funzioni. Proprio perché sarà percepito come espressione della politica e non della giurisdizione. Sistema della politica del quale dovrà integralmente accettare le regole. Restando aderenti al tema, si deve infine segnalare la intollerabile preferenza per le decisioni monocratiche, di un legislatore assillato dall’idea del risparmio e ignaro del valore della collegialità. Ciò altro non fa che completare un panorama fatto di povertà.
7. Conclusioni
In conclusione credo di avere presentato l’errore giudiziario in termini allargati sul piano della nozione e in termini complessi sul piano delle cause che lo possono determinare. Cause non certo limitate alla sua tradizionale e riduttiva trattazione.
La complessità delle moderne società, trasferita al mondo della giustizia penale, ci consegna questo tema evidenziando tratti analogamente complessi e multifattoriali.
Il populismo giustizialista, frutto della crisi dello stato sociale, ma anche della diffusa ignoranza, circostanze che generano la pressante ricerca di soluzioni demiurgiche, ha giocato (e tuttora gioca) un ruolo non trascurabile nella creazione un clima sociale favorevole alla condanna, del tutto ostile al rispetto delle necessarie garanzie viste come indebite tutele apprestate a un sicuro colpevole. Gli stessi principi costituzionali hanno subito un ridimensionamento nel disordinato immaginario collettivo e purtroppo anche in taluni settori della giustizia penale. Il quadro delle tutele processuali addirittura è stato talvolta presentato come la magna charta del reo.
Il codice del 1988 è stato storpiato da riforme restauratrici, del tutto contrarie alla sua lettera e al suo spirito. Nel mondo della legislazione penale trionfa poi il mito dell’efficientismo di pretta marca aziendalista, di conseguenza è declinata l’esigenza della qualità.
La legge penale ha rotto ormai da tempo ogni rapporto con la dogmatica, ribaltando la sua originaria subordinazione a quest’ultima. Rapporto che però le impediva di sbagliare, così finendo per cedere all’idea di un diritto penale quantitativamente enorme e asistematico. Ne è conseguita una ingestibile quantità di processi alla quale non si riesce a trovare rimedi.
L’indecente circo mediatico al quale puntualmente assistiamo assegna le responsabilità prima ancora del giudizio. L’interpretazione creativa indebitamente dilata il precetto penale. I collegi giudicanti sono frequentemente composti, così come gli organi monocratici, da magistrati ancora in fase di formazione. La rinuncia all’anzianità come criterio prioritario per l’assegnazione degli incarichi direttivi ha contribuito a scatenare il carrierismo di taluni. Le personali visioni ideologiche e il trasferimento di altrettanto personali opinioni politiche alla giustizia, hanno posto in secondo piano il principio di imparzialità, presentando la inedita figura di un giudice immerso nel sociale e, quindi, parte, anziché arbitro imparziale.
È chiaro che nessuna delle situazioni qui illustrate può dirsi finalisticamente rivolta all’errore giudiziario. Ma a questo possono ritenersi collegate da ben precisi nessi causali.
potrebbero interessarti…
News dalle Sezioni Unite
…entra

Gli approfondimenti…
Iscrivendoti alla nostra Newsletter acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Concessione del consenso per ricevere esclusivamente approfondimenti di interesse giuridico. Per ulteriori informazioni, clicca qui