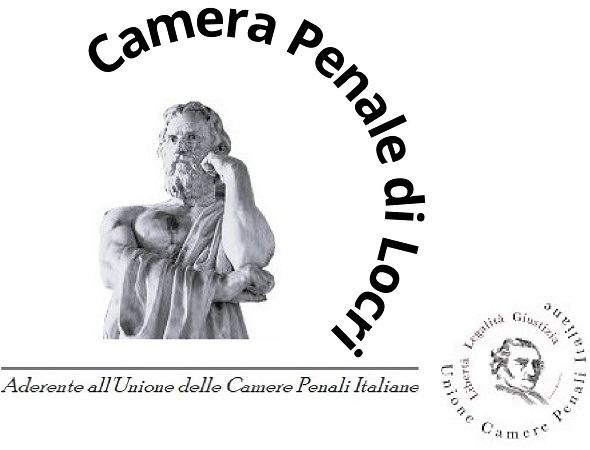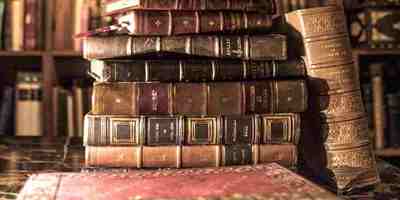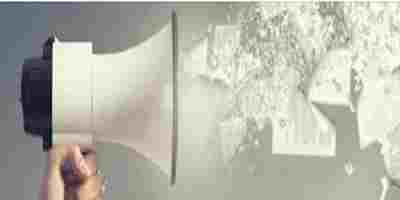A cura di Avv. Marcello Consiglio – Penalista del Foro di Palermo.
PREMESSA
Il dibattito cui vorrebbe costringerci la ANM è incentrato sulla dicotomia fuorviante apocalittici e integrati[1].
La tecnica argomentativa appare molto chiara:
- banalizzazione degli argomenti a favore, ridotti all’ingenua visione[2] di magnifiche sorti e progressive che la riforma, comunque, non potrebbe garantire poiché i problemi della giustizia si risolvono con maggiori investimenti che non si intravedono[3];
- rappresentazione di un futuro distopico dominato da un pm dei regimi autoritari dell’Europa orientale[4], fatalmente controllato dall’Esecutivo
L’obiettivo, in tutta evidenza, è quello di propagandare l’inutilità della riforma, asseritamente strumentale al successivo, inevitabile, assoggettamento del Pubblico Ministero al Governo con grave danno per i diritti dei cittadini non più garantiti da una magistratura autonoma e indipendente.
*
Per continuare nell’abituale approccio alfabetizzante dell’UCPI teso ad emancipare gli italiani da anni di retorica legalitaria, non resta che optare per un’argomentazione tecnico – divulgativa mediana rispetto ai due orientamenti estremi sopra descritti, nella consapevolezza che la politica è legata alle ondivaghe posizioni dell’opinione pubblica e che la magistratura autonoma e indipendente è garanzia fondamentale per l’esercizio della nostra libera professione[5].
La coincidenza del dibattito pubblico con la certa scadenza referendaria impone una comunicazione che, senza tralasciare le principali questioni tecniche, sappia divulgarle con relativa semplicità, avvertendo l’uditorio del metodo argomentativo dei nostri contraddittori.
Proprio per disvelare gli inganni della propaganda contraria alla riforma, gioverebbe sottolineare, in via preliminare, che l’ANM è storicamente contraria a qualsiasi riforma ordinamentale, costituzionale e no, dalla stessa non condivisa.
Uno degli esempi più significativi[6] risale alla proposta di istituire la Procura Nazionale Antimafia che, nonostante non prevedesse modifiche costituzionali, fu comunque avversata con molti degli argomenti che sentiamo oggi:
- la riforma non risolve i problemi della giustizia che soffre una cronica carenza di mezzi;
- superpoteri al procuratore nazionale con l’inevitabile sottoposizione della magistratura alla politica;
- danni irreparabili per i diritti di libertà e le garanzie dei cittadini, preconizzati con espressioni parossistiche[7].
*
Rinviando alla sintesi che segue per riassumere le principali tesi contrapposte, si rimarca la gravità del ricorrente richiamo ad un’emergenza democratica, in modo del tutto fuorviante[8] legata a legittime iniziative legislative, assuefacendo l’opinione pubblica che, in futuro, potrebbe non cogliere altri e fondati allarmi per la tutela dei diritti fondamentali e la tenuta complessiva del sistema istituzionale[9].
LE TESI CONTRAPPOSTE
Il primo gruppo di argomenti dovrebbe sottolineare l’ineluttabilità della riforma costituzionale, in evidente ritardo rispetto al recepimento del rito accusatorio nel nostro ordinamento.
Argomenti NO: la separazione tra giudice e pm, di fatto, è già esistente[10], e, quindi, la riforma è quantomeno inutile. Le numerose sentenze di assoluzione testimonierebbero l’assenza di soggezione dei giudici ai pubblici ministeri[11].
Argomenti SÌ: al di là del naturale completamento, sul piano costituzionale, del processo accusatorio (art. 111 Cost.)[12], proprio la documentata separazione di fatto tra giudice e pm, priva di qualsivoglia conseguenza negativa nella tutela dei diritti, merita una legge costituzionale che rafforzi uno status quo, ormai, pacificamente, accettato e condiviso, ma disciplinato con legge ordinaria[13].
Argomenti NO: la creazione di una magistratura requirente, con un suo CSM rafforzerà sensibilmente il pm; si allontana il pm dalla ‘cultura della giurisdizione’.
Argomento SÌ: per quanto detto al punto che precede deve rilevarsi che la separazione di fatto tra giudice e pm non ha comportato alcuna deriva poliziesca del pm che, al di là delle etichette, resta ancorato ad una dimensione ordinamentale di autonomia e indipendenza, finalmente, recepita sul piano costituzionale.
D’altra parte, qualunque significato si voglia attribuire alla formula retorica ed equivoca della ‘cultura della giurisdizione’, il perimetro codicistico dei poteri del pm non cambia di una virgola con la riforma costituzionale[14].
La riforma, inoltre, è in linea con una giurisdizione penale, ispirata, sul piano costituzionale a un giudice terzo e imparziale, accrescendone l’autorevolezza agli occhi dei cittadini. La riforma costituzionale, infatti, si inserisce in un quadro più ampio di modernizzazione del sistema giudiziario italiano, volto a garantire una maggiore efficienza e trasparenza. La separazione netta tra giudice e pm, sancita a livello costituzionale, mira a rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia, rappresentando un passo avanti verso un sistema giudiziario più equo, in cui le funzioni accusatorie e giudicanti sono chiaramente distinte, prevenendo possibili conflitti di interesse e influenze indebite.
Con due csm separati, i pubblici ministeri non decideranno della carriera dei giudici (trasferimenti, attribuzione incarichi direttivi, valutazioni professionalità).
*
Il secondo gruppo di argomenti dovrebbe mirare a contrastare la prospettiva distopica[15] di un pm straripante, appiattito sulla logica di ‘risultato’ della polizia, irrimediabilmente destinato ad essere sottoposto al controllo dell’esecutivo.
Argomenti NO: il pm “superpoliziotto”; i pubblici ministeri come gruppo potente fuori controllo; il rischio per l’autonomia del pm.
Argomenti SÌ: l’impulso irresistibile all’invocazione di un’emergenza democratica, è declinata attraverso il richiamo a sistemi giudiziari illiberali, in linea con la prospettiva apocalittica descritta in premessa. In senso contrario, proprio alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la riforma costituzionale non modifica in nulla i poteri del pm e ne cristallizza, sul piano costituzionale, l’autonomia dalla politica[16]. Ogni attività del pm resta regolata dalla legge, sotto il controllo del giudice[17].
*
Il terzo gruppo di argomenti riguarda il sorteggio dei membri togati del CSM.
Argomenti NO: il sorteggio dei membri togati del csm non ne garantisce un’adeguata selezione.
Argomenti SÌ: non si può sostenere che il sorteggio possa ritenersi, di per sé, un metodo di selezione inadeguato, considerato che, per quanto riguarda proprio la componente togata, il sorteggio avverrebbe tra i magistrati, esperti di diritto anche sui temi ordinamentali.
In questo senso, nel già citato PARERE CSM VI COMMISSIONE – ODG 8.1.25, si precisa “Torna, quindi, in evidenza il confronto, innanzi anticipato, con il diverso meccanismo di
selezione previsto per la designazione dei consiglieri laici rispetto a quello riservato alla
componente togata: “temperato” per i primi, “puro” per i secondi. Differenze che sottendono la consapevolezza da parte del legislatore della diversità dei percorsi professionali e di specializzazione che contraddistinguono la carriera del magistrato, da quella dei professori universitari e da quella, ancora diversa, degli avvocati.
Si tratta, nel primo caso, inevitabilmente e indubitabilmente, di tecnici in possesso di particolari competenze in materia di ordinamento giudiziario e, dunque, di quelle competenze specifiche necessarie a rivestire il ruolo di componente dell’organo di autogoverno della magistratura. Nel secondo caso, pur trattandosi di soggetti esperti in materie giuridiche, non è detto che si tratti di giuristi in possesso competenze specifiche in materia di magistratura e del relativo ordinamento. Si spiga così, dunque, la previsione di una selezione “a monte” della componente laica del Consiglio e, quindi, il sistema del “sorteggio temperato”.
Sul meccanismo del sorteggio si segnala in questa sede che, volendo salvaguardare un limitato carattere rappresentativo del Consiglio, pur nella consapevolezza di impedire per il futuro ogni forma di degenerazione “correntizia”, potrebbe essere opportunamente valutata la previsione del c.d. sorteggio temperato per la selezione della componente togata, sia nell’uno che nell’altro organo di autogoverno nella magistratura (giudicante e requirente). In questo senso si potrebbe prevedere un preventivo sorteggio tra tutti i magistrati (magari a partire da quelli in possesso della terza valutazione di professionalità) in modo da comporre una lista pari ad almeno il triplo dei componenti da nominare e una successiva elezione tra i sorteggiati da parte di tutti i magistrati (in questo caso a prescindere dal possesso della terza valutazione).
Ancora, altro meccanismo di sorteggio temperato potrebbe prevedere la votazione di candidati per la composizione di una lista, anche in questo caso recante un elenco almeno triplo dei componenti degli organi di governo autonomo da sorteggiare. Il primo dei due meccanismi di sorteggio temperato, verosimilmente, garantirebbe una minore capacità di condizionamento elettorale delle componenti associative rispetto al secondo…….
Si tratta di elementi sintomatici dei tratti che caratterizzano la riforma in esame e gli obiettivi che con essa il legislatore intende perseguire e, segnatamente, la valorizzazione
dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, ma al riparo dalle degenerazioni del c.d. “correntismo” che ne hanno, in certe fasi, pregiudicato l’autorevolezza.”.
All’interno della stessa magistratura, si è aperto un dibattito che, partendo dalla denuncia della deriva correntizia del CSM, ha portato a ritenere perfettamente compatibile con un quadro costituzionale un sistema di sorteggio temperato. La questione è stata talmente dibattuta da indurre l’ANM ad indire un referendum che ha confermato la diffusa condivisione, tra gli stessi magistrati, del sorteggio[18].
*
Il quarto gruppo di argomenti tratta il tema dell’Alta Corte disciplinare.
Argomenti NO: un ulteriore tassello verso la perdita di autonomia e indipendenza dei magistrati; plurime difficoltà nella prospettiva dell’adozione dei provvedimenti normativi attuativi della riforma costituzionale.
Argomenti SÌ: nessuna incidenza sull’autonomia e indipendenza della magistratura, considerato che la maggioranza dell’Alta Corte è sempre dei magistrati; nessuna difficoltà insuperabile sul piano delle norme di attuazione.
Sul piano comparativo come correttamente indicato nel più volte citato PARERE CSM VI COMMISSIONE – ODG 8.1.25 “Al riguardo, non si può omettere di rilevare che l’istituzione di un giudice disciplinare esterno agli istituendi Consigli superiori delle magistrature giudicante e requirente dovrebbe essere accompagnata da analoga previsione che portasse attribuzione all’Alta Corte, attraverso specifiche integrazioni nella composizione, della giurisdizione sugli illeciti della magistratura amministrativa, contabile, tributaria e militare e ciò con l’obiettivo di garantire la formazione di un corpus di diritto vivente disciplinare comune per tutte le magistrature della Repubblica.
Il modello di cui si tratta, peraltro, riflette quello già adottato in diversi Paesi europei, laddove la gestione della disciplina dei magistrati è affidata a organi esterni alle istituzioni di autogoverno.
Così, a titolo esemplificativo, in Belgio il Tribunal disciplinaire e la Corte d’appello disciplinare hanno competenza disciplinare sui magistrati, mentre il Conseil Supérieur de la Justice non svolge le funzioni di autogoverno. In Germania, i procedimenti disciplinari sono affidati al Dienstgericht, un Tribunale federale esterno. In Inghilterra e in Galles, inoltre, la potestà disciplinare è esercitata dal Lord Chancellor e dal Lord Chief Justice, supportati dall’Office for Judicial Complaints, indipendente rispetto al Judges Council of England and Wales.
In questo contesto, l’Italia si allineerebbe ad una tendenza europea che prevede la trattazione degli affari disciplinari a carico dei magistrati, ad istituzioni indipendenti dall’organo di autogoverno, come previsto nei Paesi Bassi, in Austria e in Polonia, laddove gli organi disciplinari sono indipendenti dai consigli della magistratura per soddisfare istanze di terzietà e scongiurare il rischio di influenze politiche o conflitti di interesse.”. L’adozione di un sistema disciplinare esterno alle istituzioni di c.d. autogoverno dei magistrati[19] garantirebbe una maggiore imparzialità e farebbe crescere la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario, rafforzando la percezione di trasparenza e neutralità. La terzietà dell’Alta Corte disciplinare garantirebbe un controllo più rigoroso e imparziale, prevenendo potenziali conflitti di interesse e assicurando che i magistrati siano giudicati con equità e obiettività.
Infine, l’adozione di un sistema disciplinare esterno può incentivare una maggiore responsabilità tra i magistrati stessi. Sapendo di essere sottoposti a un controllo esterno e indipendente, i magistrati potrebbero essere più motivati a mantenere standard professionali elevati. Questo, a sua volta, potrebbe contribuire a migliorare la qualità complessiva del sistema giudiziario, a beneficio di tutti i cittadini.
CONCLUSIONI
Su questi temi, l’Avvocatura penale italiana, interlocutrice laica e indipendente, autonoma nei propri giudizi politici, ispirati da una radicata virtù costituzionale, auspica un perimetro di leale collaborazione tra i Poteri istituzionali[20] che consenta di coltivare l’alta ambizione di offrire un servizio giustizia efficiente, in un rinnovato quadro ordinamentale.
[1] Nell’accezione usata da Umberto Eco per descrivere l’atteggiamento degli intellettuali rispetto alla cultura di massa.
[2] Quella, appunto degli integrati.
[3] Si ritiene che questo ed altri argomenti utilizzati nella comunicazione/propaganda dell’ANM (cfr. brochure che si apre con la domanda di che cosa ha davvero bisogno la giustizia?), prima che contestati nel merito, vadano denunciati come eccentrici rispetto al tema della riforma e quindi evidentemente fuorvianti, seguendo un metodo argomentativo suggerito da accreditata scienza cognitiva e linguistica “quando state discutendo con i vostri avversari non usate mai il loro linguaggio, o finirete con l’evocare le stesse idee, rinforzandole” (Non pensare all’elefante George Lakoff).
[4] Gli apocalittici, tra molti, Gialuz (Sistema penale 9/2024) Insomma, con due Consigli si finirebbe per dare vita ad «una sorta di “Prokuratura” della funzione d’accusa, organo destinato a scaricare nell’ordinamento la forza sostanziale ed inquietante della funzione d’accusa, forza accresciuta da essere protetta, garantita e rappresentata da un organismo esponenziale separato e del tutto autonomo e non responsabile». Questa magistratura requirente, protetta e garantita dal suo CSM, finirà per acquisire un ruolo e un peso che, prima o poi, sarà necessario intervenire di nuovo. Per ricondurre la corporazione dei PM al circuito democratico, verosimilmente sottoponendola all’esecutivo.
[5] Convincimento che sbaglieremmo a ritenere incrollabile in un’opinione pubblica e in gran parte della sua rappresentanza politica che, storicamente, oscillano tra il servo encomio e il codardo oltraggio.
[6] In disparte, le critiche della magistratura associata contro Giovanni Falcone che si era limitato a fotografare l’ovvia separatezza dei ruoli di pm e giudice nel nuovo processo accusatorio. La posizione di Falcone tendeva a ridefinire un profilo autonomo del pm rispetto al giudice, nell’ottica di una più incisiva azione giudiziaria, ma per il solo fatto di aver toccato un tema ordinamentale, richiedendo che fossero due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, fu bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell’Esecutivo (Falcone, intervista a Mario Pirani).
[7] L’ex presidente dell’Anm Raffaele Bertoni, si spinse addirittura ad affermare che la superprocura antimafia sarebbe stata in magistratura “quello che la cupola è nella mafia”……. La procura nazionale antimafia, così, venne istituita secondo un modello certamente innovativo, ma depotenziato rispetto alle premesse iniziali. Sebbene i poteri gerarchici del nuovo organismo fossero stati eliminati, la magistratura associata continuò a lungo a criticare fortemente la creazione della Dna, considerandola un tentativo di gerarchizzare l’ufficio del pubblico ministero e assoggettarlo all’esecutivo. Proprio queste preoccupazioni legate a una limitazione dell’indipendenza della magistratura, spinsero la commissione incarichi direttivi del Csm a respingere la nomina a superprocuratore di Falcone, ritenuto troppo vicino al governo, e a preferirgli Agostino Cordova. In seguito, la procedura di nomina non si concluse a causa dell’uccisione di Falcone nella strage di Capaci. La travagliata nomina del primo procuratore nazionale antimafia si concluse solo nell’ottobre 1992, con la nomina di Bruno Siclari, all’epoca procuratore generale a Palermo. (Le ali dell’Antimafia Ermes Antonucci, il Foglio, 06 set 2021). Questa efficace sintesi giornalistica conferma il metodo argomentativo fuorviante e propagandistico che dissimula il rifiuto di qualsivoglia modifica ordinamentale non dettata dalla magistratura e la logica partitocratico – correntizia delle nomine dirigenziali che ha travolto anche magistrati di straordinario valore come Giovanni Falcone.
[8] Ricordiamo sempre che, ad esempio, l’assetto ordinamentale portoghese della separazione delle carriere fu introdotto, in Portogallo, alla caduta del regime fascista instaurato da Salazar.
[9] Si impone, semmai, un’alta sorveglianza sulle possibili involuzioni verso forme di democrazie autoritarie, di tipo diverso, ma tutte segnate da un attacco agli organi di garanzia (in particolare, le Corti Costituzionali). Si avverte, infatti, l’esigenza di uno sguardo più ampio sul parallelo progetto di riforma costituzionale (c.d. premierato) o su eventuali proposte di modifica della legge elettorale, avuto riguardo, in particolare, all’eventuale mutamento del collegio per l’elezione del Presidente della Repubblica e considerata (Ceccanti, Giustizia insieme) la necessità di rendere indisponibile la carica a una scelta della sola maggioranza che potrebbe incidere anche sull’effettivo esercizio dei poteri relativi, tra l’altro, alla nomina di alcuni componenti della Corte Costituzionale, nonché dell’istituenda Alta Corte disciplinare.
[10] Si ponga attenzione all’argomento suggestivamente fuorviante della presunta separazione delle magistrature e non della ‘semplice’ separazione delle carriere (Gialuz cit.): in senso contrario si rileva che l’ordine giudiziario resta unico (art. 104 comma 1 prima parte – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere). In questo senso si è correttamente precisato (PARERE CSM VI COMMISSIONE – ODG 8.1.25 – si fa riferimento, in questo e negli altri passaggi alla, PROPOSTA B Cons. relatore Giuffrè) Con riferimento al primo aspetto, la riforma modifica l’art. 102 della Costituzione prevedendo che le norme sull’ordinamento giudiziario disciplinano le carriere “distinte” dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, i quali a loro volta – come sancito dal riformulato art. 104 Cost. – compongono la magistratura, “ordine” autonomo e indipendente da ogni “altro” potere.
A tal riguardo, si osservi come il testo del disegno di legge costituzionale abbia mantenuto il termine “altro” proprio per rafforzare i principi dell’autonomia e dell’indipendenza dei pubblici ministeri.
[11] I giudici condannano soltanto nel 40,4% dei casi (dalla brochure dell’ANM sopra indicata). In disparte il dato affatto tranquillizzante dell’elevata percentuale di azioni penali esercitate ed evaporate in dibattimento, a tutto concedere, vale sempre il principio che la riforma in discussione cristallizzerebbe sul piano costituzionale uno stato di fatto che gli stessi magistrati ritengono fisiologico e che, indubbiamente, si può ritenere il frutto della progressiva separazione di funzioni tra pm e giudici, sancito da legge ordinaria.
[12] Si consideri che il richiamo al completamento costituzionale del processo accusatorio richiama (Gialuz Sistema penale 9/2024 p. 77) l’argomento della giuria e del verdetto immotivato, ovviamente come prospettiva non auspicabile. Giova ricordare sempre che la prospettiva comparativista non è mai tal quale, considerato che ogni ordinamento ha una sua storia e propri processi di adattamento.
[13] In questo senso cfr. PARERE CSM VI COMMISSIONE – ODG 8.1.25 – Ebbene, il quadro statistico appena riportato vale a dimostrare in concreto come la distinzione delle funzioni sia ormai percepita dalla stessa magistratura come un fatto acquisito in termini di attitudini personali e professionali e come, dunque, appaia ormai maturo il tempo per sciogliere definitivamente ogni profilo di ambiguità, riallineando con la revisione del Titolo IV della Carta del 1948 i piani costituzionale, ordinamentale e processuale.
[14] In disparte la considerazione che il pm non può essere organo di giustizia perché l’art. 358 cpp e il controllo sull’esercizio dell’azione penale servono al buon andamento del servizio e non dimostrano l’imparzialità del pm (Zanon).
[15] Cfr. Gialuz (Sistema penale cit. p. 84)
[16] In questo senso cfr. PARERE CSM VI COMMISSIONE – ODG 8.1.25 È noto, al riguardo, come la magistratura associata abbia manifestato la preoccupazione che la separazione delle carriere possa compromettere i richiamati presidi costituzionali, attraendo, in una prospettiva più o meno vicina, l’ufficio del Pubblico ministero al Potere esecutivo. Tuttavia, il primo comma del nuovo articolo 104 della Costituzione garantisce che la magistratura, sia giudicante sia requirente, resti autonoma e indipendente esercitando le proprie funzioni senza pressioni, condizionamenti o interferenze, libera di agire secondo il proprio giudizio e secondo la legge, impedendo che il Potere esecutivo, le altre istituzioni o, a maggior ragione, poteri privati, possano intervenire direttamente o indirettamente nelle attività della inquirente e requirente.
Si deve sottolineare in proposito che l’autonomia e l’indipendenza del pubblico ministero rimangono inalterati, non solo perché il pubblico ministero continuerà a far parte dell’ordine giudiziario, ma ancor più in quanto sarà creato un organo di governo autonomo specificamente preposto alla garanzia dei principi di autonomia e indipendenza ribaditi nel d.d.l. di revisione costituzionale.
Sotto tale aspetto, il timore che tale organo possa contribuire alla formazione di un corpo autonomo e autoreferenziale appare privo di fondamento. Invero, l’idea che un corpo di magistrati requirenti autonomi rappresenti “il potere dello Stato più forte che si sia mai avuto in alcun ordinamento costituzionale dell’epoca contemporanea” (A. Pizzorusso, La Costituzione ferita, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 149) non sembra considerare le garanzie costituzionali e legislative che già oggi regolano il profilo ordinamentale e processuale del pubblico ministero. Anche i magistrati requirenti sono, infatti, tenuti al rispetto della Costituzione, delle leggi e dei limiti rappresentati dalle prerogative degli altri Poteri dello Stato. Inoltre, l’organo di autogoverno della magistratura requirente continuerà ad essere presieduto dal Presidente della Repubblica, così assicurando, attraverso lo sperimentato meccanismo della c.d. “eteropresidenza”, quelle garanzie di autonomia e di indipendenza verso l’interno e verso l’esterno, ma anche di equilibrio rispetto alla magistratura giudicante e agli altri Poteri dello Stato. Del resto, anche il CSM requirente sarà composto per un terzo da membri c.d. “laici” e ciò contribuirà a fornire una visione integrata dei molteplici interessi costituzionali coinvolti nell’attività di governo autonomo della magistratura requirente.
Permangono, inoltre, immutate le altre disposizioni costituzionali del Titolo IV che contribuiscono a definire lo “statuto” del pubblico ministero e, segnatamente, gli articoli 109 e 112 Cost. Come sottolineato nella Relazione di accompagnamento al testo del d.d.l. in discussione e tale scelta si pone in continuità e sintonia “con la storia costituzionale italiana e con l’interpretazione della Corte Costituzionale”.
[17] In particolare, nella delicatissima fase delle indagini preliminari, avuto riguardo all’applicazione delle misure cautelari personali e reali.
[18] Nelle date del 27 e 28 gennaio 2022 si è svolto, con voto online, un referendum consultivo indetto a norma dell’art. 55 dello Statuto dell’ANM. Il primo quesito riguardava il metodo del sorteggio: su 7.872 elettori, hanno espresso la loro preferenza 4.275 magistrati, con un’affluenza pari al 54,31%. Per il ‘No’ al sorteggio sono stati espressi 2.475 voti, mentre per il ‘Si” le preferenze sono state 1.787.
[19] Non dimentichiamo che tra le critiche vi è la limitazione della competenza dell’Alta Corte alla magistratura ordinaria. Questo rilievo non mina alcuno degli argomenti a favore anzi prova troppo: se si ritiene estendibile la riforma a tutte le magistrature non si vede perché non applicarla, in prima battuta, alla magistratura ordinaria. In ogni caso si può sostenere che questo è il primo tassello di un’auspicabile, progressiva integrazione delle giurisdizioni sugli illeciti della magistratura amministrativa, contabile, tributaria e militare all’interno dell’Alta Corte, favorendo, così, lo sviluppo di un corpus giuridico uniforme, riducendo le disparità di trattamento e rendendo più trasparente l’intero sistema disciplinare.
[20] Presidente UCPI Francesco Petrelli, Inaugurazione dell’Anno giudiziario dei penalisti italiani 2025.
potrebbero interessarti…
News dalle Sezioni Unite
…entra

Gli approfondimenti…
Iscrivendoti alla nostra Newsletter acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Concessione del consenso per ricevere esclusivamente approfondimenti di interesse giuridico. Per ulteriori informazioni, clicca qui