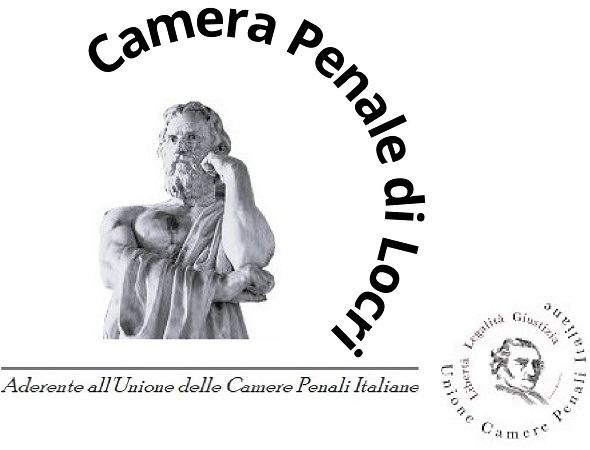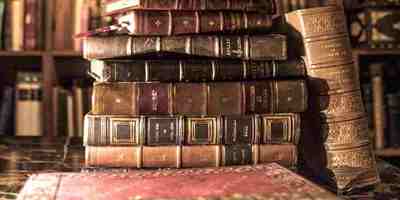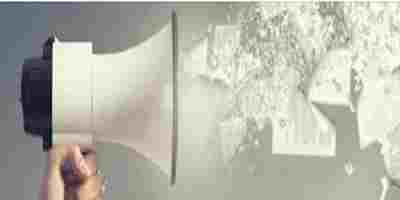La Prima Sezione, con la pronuncia in esame ha enucleato due importanti principi di diritto.
Con il primo è stato affermato che “l’esito dell’indagine genetica condotta sul DNA, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, lungi dall’avere valore meramente indiziario, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ha natura di prova dell’identità del contributore, sicché costituisce a carico del medesimo la prova del fatto-reato, secondo un percorso logico deduttivo che poggia sulla particolare localizzazione della traccia e dei rapporti tra le parti, in forza dei quali debba escludersi un contatto da trasferimento secondario od occasionale”.
Con il secondo principio si è ribadito che “ferma la possibilità di disporre il prelievo coatto, il rifiuto opposto a una richiesta di accertamento non invasivo e non comportante atti di disposizione della propria sfera corporale, quando non sia motivato da ragioni esplicitate e giustificate, può essere liberamente apprezzato dal giudice nella formazione del suo convincimento; in particolare, il rifiuto può essere utilizzato come elemento di prova della natura non accidentale del contatto, dei tempi e dei modi di rilascio delle tracce biologiche rilevate sulla vittima. Infatti, l’ingiustificato rifiuto di sottoporsi al prelievo non invasivo, unito all’assenza di attendibili e tempestive indicazioni di possibili trasferimenti secondari od occasionali idonei a giustificare la presenza della traccia biologica dell’imputato, consente al giudice di affermare che detta traccia biologica rilevata sul corpo della vittima è dimostrativa dell’azione omicida dell’imputato.”
A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)
La Corte di Assise di appello di L’Aquila confermava la sentenza emessa dal giudice di primo grado nei confronti di un soggetto accusato del reato di omicidio e condannato – previa riduzione ex art. 438 c.p.p. stante l’avvenuta esclusione delle circostanze aggravanti a effetto speciale originariamente contestate (le quali non avevano inizialmente permesso all’imputato di chiedere l’accesso al rito abbreviato) – alla pena di anni quindici di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.
Secondo la tesi accusatoria, il fatto omicidiario si sarebbe verificato a seguito della condotta violenta dell’imputato che avrebbe colpito la vittima, in varie parti del corpo, con ventidue colpi mediante l’uso di uno scalpello o cesello e di un martello.
Orbene, sia la Corte territoriale sia la Corte d’Assise sono giunte ad affermare la penale responsabilità dell’imputato alla luce degli accertamenti tecnico-scientifici volti a comprendere, attraverso una consulenza anatomopatologica, le cause della morte e a comparare ed analizzare il tracciato del DNA dell’accusato con le tracce rinvenute sul corpo della vittima.
I giudici di merito hanno, infine, valorizzato il contenuto dei tabulati telefonici, delle dichiarazioni testimoniali e di quelle consulenziali.
Ciò posto, secondo la ricostruzione giudiziale, l’omicidio sarebbe stato commesso da una sola persona che avrebbe aggredito la vittima all’interno del suo laboratorio con numerosi colpi inferti con uno strumento da taglio e un martello (strumenti, tra l’altro, rinvenuti sulla scena del crimine).
La vittima sarebbe stata successivamente spostata dall’effettivo locus commissi delicti e trascinata per le gambe (per essere nascosta) fino all’interno del suindicato laboratorio al fine di ostacolarne il rinvenimento.
La certa individuazione dell’imputato quale autore del reato – secondo la tesi sostenuta tanto dai giudici di primo che di secondo grado – sarebbe avvenuta attraverso la comparazione del profilo genetico del medesimo (cui lo stesso si era opposto) con le tracce lasciate sui pantaloni della persona offesa.
Inoltre, i giudici di merito avevano conferito particolare importanza al fatto che l’imputato si fosse trovato nelle vicinanze del luogo dell’omicidio in occasione della consumazione del fatto criminoso evidenziando la falsità dell’alibi fornito dall’accusato.
L’imputato, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di appello di L’Aquila.
La Prima Sezione, investita del gravame, lo rigettava sulla base delle argomentazioni giuridiche, di seguito, indicate.
Preliminarmente, devesi rilevare che il ricorrente aveva chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza lamentando la violazione di legge e il vizio della motivazione del provvedimento giudiziale stante la ritenuta insussistenza di sufficienti elementi a carico dell’imputato tali da giungere a una sentenza di condanna e il mancato esame, da parte dei giudici del merito, di ipotesi alternative dotate di alta credibilità idonee a dimostrare l’estraneità dell’accusato al fatto allo stesso contestato.
In tal senso, il ricorrente lamentava:
- l’omesso accertamento del momento in cui è effettivamente avvenuto il trasferimento del DNA dell’imputato sui pantaloni della vittima;
- la non univocità del predetto elemento probatorio;
- il fatto che i giudici di merito avessero fatto leva, al fine di pervenire a una sentenza di condanna, sul rifiuto opposto dall’imputato al prelievo di un campione del proprio materiale genetico;
- l’illegittimo utilizzo, da parte dei giudici di merito, delle dichiarazioni rese dall’imputato alla P.G. che lo aveva esaminato in qualità di persona informata sui fatti in ordine al rinvenimento del suo DNA sui pantaloni della vittima (trattavasi, secondo il ricorrente, di dichiarazioni non utilizzabili poiché in contrasto con quanto previsto dal codice di rito);
- il vizio di motivazione in cui sarebbero incorsi i giudici di merito che avrebbero erroneamente e immotivatamente giudicato non plausibili e non dimostrate le giustificazioni offerte dall’imputato in ordine alla sua presenza nelle vicinanze dell’abitazione della vittima in occasione dell’omicidio.
Ciò posto, la fondamentale questio iuris, oggetto della motivazione della sentenza resa dalla Prima sezione, ruota attorno:
- al valore probatorio da assegnare all’esame del DNA;
- alla rilevanza da assegnare alla datazione del medesimo;
- alla compatibilità tra il DNA dell’imputato e le tracce rinvenute sugli indumenti della vittima.
In tal senso, i Giudici di legittimità hanno evidenziato come “in tema di prove, gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA hanno natura di prova piena e non di mero elemento indiziario, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, sicché sulla loro base può essere affermata la penale responsabilità dell’imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti” (cfr. Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Cospito).
Orbene, nel caso di specie non è stata contestata (dal ricorrente) l’identità tra il DNA rinvenuto sui pantaloni della vittima e quello dell’imputato stante l’elevatissimo indice di identificazione riscontrato (nel caso di specie, difatti, l’indice è stato pari a 1023 e la scienza considera sufficiente per la certa identificazione un indice superiore a 106).
La contestazione aveva, invece, ad oggetto la mancata individuazione – da parte dei giudici di merito – dell’esatto momento temporale in cui si sarebbe verificato il “trasferimento” al fine di mettere in discussione la decisività della traccia da contatto.
Difatti, secondo la difesa, la semplice attribuzione del DNA all’imputato costituirebbe “un indizio poiché rappresenta un fatto statico (presenza di una traccia), rispetto al fatto da provare (omicidio) che è caratterizzato da una azione dinamica”.
I giudici di legittimità non hanno condiviso la tesi del ricorrente sostenendo come la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello abbiano correttamente attribuito “valore di prova (e non di semplice indizio) all’identificazione genetica compiuta per mezzo dell’analisi del DNA, [dal momento che] la traccia appartiene senza ombra di dubbio all’imputato, con ciò facendo corretta applicazione del principio di diritto costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale «gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.»” (cfr. Sez. 1, n. 48349 del 30/06/2004, Rizzetto; Sez. 2, n. 43406 del 01/06/2016, Syziu; Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, Mariller).
Inoltre, la Prima sezione ha evidenziato l’assenza di una specifica contestazione volta a censurare il fatto che le tracce biologiche dell’imputato fossero state individuate esattamente sui pantaloni della vittima all’altezza delle caviglie della medesima.
La localizzazione delle tracce (sulle caviglie della p.o.) era, pertanto, compatibile con un’attività di trascinamento del corpo compiuta dall’aggressore una volta commesso il fatto omicidiario.
Non è stata, in tal modo, messa in discussione la casualità del contatto.
In tal senso, i Giudici di legittimità hanno sottolineato come sia “logico affermare, per attribuire al ritrovamento del DNA la valenza di prova dell’omicidio, che la posizione bilaterale delle tracce, rinvenute su entrambe le gambe dei pantaloni, e la loro localizzazione, in coincidenza delle caviglie della vittima, costituiscono due specifici elementi di prova che riportano dette tracce all’azione di trascinamento del corpo compiuta dall’omicida, così assegnando al DNA una valenza di prova dell’azione violenta e non solo del contatto tra aggressore e vittima”.
La predetta prova, di conseguenza, “abbraccia” anche la responsabilità per l’omicidio dal momento che la traccia genetica trovavasi in una specifica e particolare posizione tale da escludere la contaminazione casuale.
Nel caso di specie, ad avviso della Prima sezione, non è stato possibile dare applicazione al principio di diritto secondo cui “in tema di indagini genetiche, l’analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di “compatibilità” del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori”.
Secondo i Giudici di legittimità – in assenza di specifici elementi idonei a dimostrare il c.d. trasferimento secondario od occasionale – la tesi sostenuta dalla difesa è stata qualificata come mera ipotesi congetturale, indimostrata e implausibile.
Il dato superiormente esposto ha trovato il suo fondamento proprio nella genericità delle dichiarazioni dell’imputato (il quale ha semplicemente specificato che “un certo giorno c’erano dei capi di abbigliamento sul tavolo nell’abitazione della vittima”).
Ciò posto, devesi ulteriormente evidenziare che la difesa ha contestato l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato in occasione dell’attività di indagine svolta dalla P.G. chiedendo, conseguentemente, “l’espunzione [delle stesse] dal panorama probatorio”.
Orbene, la Suprema Corte non ha condiviso la tesi difensiva sostenendo che “le dichiarazioni della persona che fin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato; restano invece al di fuori della sanzione di inutilizzabilità comminata dal secondo comma dell’art. 63 cod. proc. pen. le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall’inizio indizi a suo carico, poiché rispetto a questi egli si trova in una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone; restano escluse altresì dalla sanzione di inutilizzabilità, alla stregua della “ratio” della disposizione, ispirata alla tutela del diritto di difesa, le dichiarazioni favorevoli al soggetto che le ha rese ed a terzi, quali che essi siano, non essendovi ragione alcuna di escludere dal materiale probatorio elementi che con quel diritto non collidono” (cfr. Sez. U, n. 1282 del 09/10/1996 – dep. 1997, Carpanelli).
Di conseguenza, l’imputato si è ritrovato a utilizzare le proprie dichiarazioni per difendersi e ne ha contemporaneamente dedotto l’inutilizzabilità.
Ciò posto, sulla scorta del ragionamento giuridico globalmente considerato, la Prima sezione ha, in via primaria, enucleato il principio di diritto secondo cui “l’esito dell’indagine genetica condotta sul DNA, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, lungi dall’avere valore meramente indiziario, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ha natura di prova dell’identità del contributore, sicché costituisce a carico del medesimo la prova del fatto-reato, secondo un percorso logico deduttivo che poggia sulla particolare localizzazione della traccia e dei rapporti tra le parti, in forza dei quali debba escludersi un contatto da trasferimento secondario od occasionale”.
Nel caso di specie, il rifiuto immotivato di sottoposizione al prelievo non invasivo di un campione biologico (ai fini di estrarre il DNA da raffrontare con quello rinvenuto sulla scena del crimine) è da qualificarsi come elemento di prova a carico dal momento che l’opposizione dell’imputato è stata perentoria, reiterata e immotivata “quando non soltanto non era indagato, ma anzi quando neppure era tra i sospettati”.
In casi consimili, devesi rilevare che la ferma (e al contempo immotivata) volontà di non sottoporsi al prelievo può costituire oggetto di attenta valutazione giudiziale dal momento che “il rifiuto dell’imputato di consegnare o lasciar prelevare materiale biologico utile alla comparazione del DNA, quando non siano state prospettate allo scopo modalità invasive o comunque lesive dell’integrità e della libertà personale, costituisce, se non motivato con giustificazioni esplicite e fondate, elemento di prova valutabile dal giudice a fini di ricostruzione del fatto” (cfr. Sez. 2, n. 44624 del 08/07/2004, Alcamo; Sez. 1, n. 37108 del 20/09/2002, Peddio).
Il superiore e consolidato orientamento giurisprudenziale non è stato “scalfito” dalle modifiche normative introdotte con la legge 30 giugno 2009, n. 85, a seguito delle quali è stato introdotto l’art. 224 bis c.p.p. rubricato “Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale” (trattasi di prelievo coattivo ossia di un caso non verificatosi nella fattispecie in esame).
In tal senso, giova evidenziare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 1996, aveva dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell’ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge”.
Orbene, tale pronuncia del Giudice delle leggi non ha in alcun modo influito sulla regola di giudizio secondo la quale è attribuibile rilievo probatorio “al rifiuto opposto dall’indagato di consentire il prelievo di campioni biologici in modo non invasivo, similmente a quanto accade per analoghi comportamenti oppositivi”.
Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma contenuta nell’art. 224 c.p.p. ha determinato la inutilizzabilità di qualsiasi risultato derivante “da prova biologica eventualmente conseguita in contrasto con il rispetto della libertà personale dell’imputato”.
Di conseguenza, in caso di “rifiuto […] su mere attività esterne”, esso “non può dirsi motivato da ragioni inerenti all’invasione della propria sfera corporale e alla violazione della libertà”.
Il punto cruciale ruota attorno all’ “ingiustificato rifiuto di fornire, senza alcuna invasione della libertà personale, un campione biologico da utilizzare in una indagine giudiziaria”.
Nel caso di specie, l’accertamento in questione aveva a oggetto il prelievo di saliva (ossia un’operazione per nulla invasiva, del tutto indolore e possibile senza intervento di estranei sul corpo dell’imputato).
Di tal che, il rifiuto reiterato opposto dall’imputato (stante l’assenza di adeguate giustificazioni sul punto) ha indotto il giudicante a valutare negativamente il predetto comportamento.
Pertanto, secondo la Prima sezione, il ragionamento dei giudici di merito – con specifico riguardo al valore negativo da assegnare al rifiuto immotivato opposto dal soggetto destinatario di un accertamento non invasivo – è immune da vizi logici e/o giuridici.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha enucleato il principio di diritto secondo cui “ferma la possibilità di disporre il prelievo coatto, il rifiuto opposto a una richiesta di accertamento non invasivo e non comportante atti di disposizione della propria sfera corporale, quando non sia motivato da ragioni esplicitate e giustificate, può essere liberamente apprezzato dal giudice nella formazione del suo convincimento; in particolare, il rifiuto può essere utilizzato come elemento di prova della natura non accidentale del contatto, dei tempi e dei modi di rilascio delle tracce biologiche rilevate sulla vittima. Infatti, l’ingiustificato rifiuto di sottoporsi al prelievo non invasivo, unito all’assenza di attendibili e tempestive indicazioni di possibili trasferimenti secondari od occasionali idonei a giustificare la presenza della traccia biologica dell’imputato, consente al giudice di affermare che detta traccia biologica rilevata sul corpo della vittima è dimostrativa dell’azione omicida dell’imputato”.
Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 645 / 2025, 21.11.2024 (ud), dep. 08.01.2025
potrebbero interessarti…
Gli approfondimenti…
News dalle Sezioni Unite
…entra

Iscrivendoti alla nostra Newsletter acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Concessione del consenso per ricevere esclusivamente approfondimenti di interesse giuridico. Per ulteriori informazioni, clicca qui