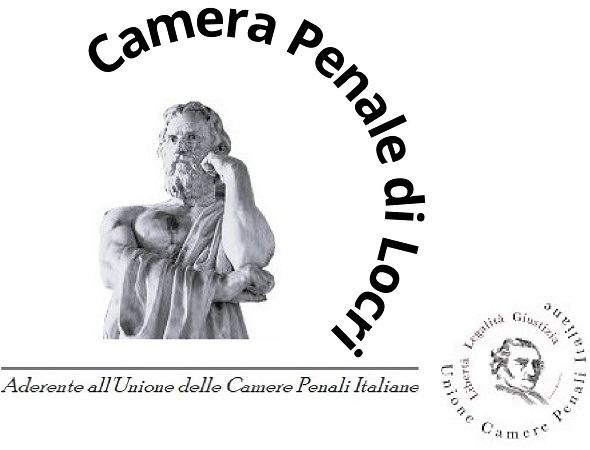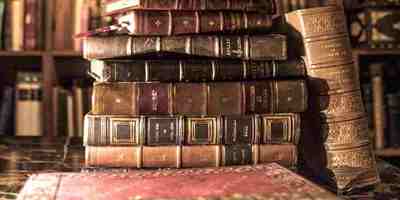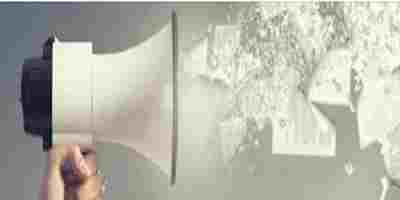Grazie Bruno,
per aver mantenuto la promessa fatta, in occasione della presentazione del tuo libro, con questo pamphlet che ci offre ulteriori argomenti di riflessione, utili per comunicare ed informare i cittadini sull’importanza della riforma costituzionale finalizzata a separare le carriere dei magistrati requirenti da quelli giudicanti;
grazie per l’impegno che hai messo nella ricerca storica e documentale con cui meglio potremo combattere quella antica e nefasta tecnica usata dai detrattori della riforma, costruita con “slogans ripetuti continuamente, finché anche l’ultima persona sia arrivata a coglierne l’idea” che, invece, illudono chi li ascolta ma non corrispondono alla realtà;
grazie da parte della nostra Camera Penale “Giuseppe Simonetti” di cui sei virtualmente socio, quale Locrese, attribuzione che è per noi motivo di orgoglio identitario nella comune battaglia che ci vedrà uniti.
Con stima e affetto
Antonio Alvaro – presidente della Camera Penale di Locri
A dicembre dell’anno scorso, nel bellissimo borgo di Gerace, durante la presentazione del romanzo “Gli spettri di Dike – Exeplum”[1], inevitabilmente la discussione si è indirizzata sull’attualità del progetto di riforma del Titolo IV della Costituzione. Gli autorevoli e preziosi interventi del prof. Ilario Ammendolia, del dott. Antonio Baldassarre e dell’avv. Giuseppe Calabrese, moderati dall’amico avv. Antonio Alvaro, Presidente della Camera Penale di Locri, sono stati un franco e leale confronto sui differenti punti di vista.
___________________________________________________________________________
[1] Bruno Larosa, Gli Spettri di Dike – Exemplum, La Bussola, 2024.
A cura di Bruno Larosa – penalista del Foro di Napoli.
Subito dopo l’evento ho accolto l’invito di scrivere quanto avevo disordinatamente sostenuto, e ora l’eseguo con inescusabile ritardo senza voler assegnare ad esso nessuna valenza scientifica e rimarcando che, a mio parere, la separazione delle carriere tra il Giudice e il P.M. è nevralgica, seppur non risolutiva, per un ormai ineludibile miglioramento del servizio della giustizia penale, anzitutto per coloro che hanno una visione progressista della società e, a maggior ragione, lo è per quanto è risultato da un recente sondaggio, condotto da Alessandra Ghisleri per “LA7”: “Gli italiani hanno paura della giustizia”[1]. Il che è un pericoloso segno di sfiducia del Popolo verso un’istituzione statale indispensabile che, per poter adempiere al meglio al proprio ruolo, deve poter godere della fiducia incrollabile di tutti[2].
Sulla separazione delle carriere, da oltre un secolo, si è detto e scritto molto, facendolo, gli sfavorevoli, con l’uso di slogan che, propagandosi sino all’infinito – affinché “anche l’ultima persona, arrivi a coglierne l’idea”[3] -, comportano una semplificazione condivisa del rischio, giungendo a quel giudizio affrettato che è proprio delle “affermazioni categoriche”, fatte da chi, nel pubblico, dà l’impressione di sapere cosa sta dicendo, generando quella che i neuroscienziati chiamano “fenomeno della verità illusoria”[4]. Gli elementi che caratterizzano questo fenomeno ci sono tutti: leader riconosciuti e autorevoli; un avversario che, con le sue proposte, appaia di volta in volta un pericolo concreto; l’uso di slogan che prefigurano scenari tragici; la ripetizione continua di questi detti; una condizione di tribalismo da parte dei maggiori organi di informazione.
La realtà, invece, è ben diversa e si svela solo attraverso il ragionamento logico e con la matura conoscenza delle dinamiche processuali e storico-politiche che riguardano l’argomento.
Non potendo immaginare che quanti sono contrari alla separazione delle carriere, ignorino il substrato storico-culturale nel quale si è formata e alimentata l’attuale proposta di riforma costituzionale, devo dedurne che le loro affermazioni siano una manifestazione di slealtà istituzionale, con l’obiettivo, da una parte, di continuare ad assicurare il potere che i Padri costituenti non intendevano attribuire, dall’altra, seguitare a fungere da ipocrite ancelle, ossequiose di quell’Ordine, peraltro senza più ritrovarsi con la propria tradizione politica. uesto QCiò avviene a danno della giurisdizione penale, ispirata costituzionalmente a un giudice rispettoso della legge, terzo e imparziale.
L’obiettivo che mi propongo, dunque, è di provare a disabituare[5] il cittadino rispetto agli effetti che derivano da questo continuo stillicidio di affermazioni persuasive, ma irreali.
Da autorevoli personalità che occupano le pagine dei giornali e i salotti televisivi, sentiamo ripetere che:
- A) “Questa riforma è un attentato alla Costituzione… che essa nasconde il vero scopo del Governo che vuole sottoporre i PM alle sue dipendenze o a quelle del Ministro della Giustizia”[6].
Una “rottura con la Costituzione”, in questo caso, è davvero impensabile: il nuovo testo è all’esame del Parlamento, ed è trattato con la procedura prevista dall’art. 138 della Costituzione.
D’altronde sulla legittimità della separazione delle carriere dei magistrati e della sua compatibilità anche con l’attuale testo costituzionale, si è incidentalmente espressa la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 del 3-7 febbraio 2000 quando, dovendo giudicare sull’ammissibilità del referendum abrogativo dell’art. 190 comma 2 dell’Ordinamento Giudiziario, riguardo alla possibilità di passaggio delle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa, la Corte ha fatto due affermazioni di particolare interesse:
1) che quel quesito referendario non investiva le disposizioni il cui contenuto normativo essenziale fosse costituzionalmente vincolato, con la conseguenza che il referendum sulla materia era ammissibile;
2) che “La Costituzione, infatti, pur considerando la magistratura come un unico “ordine”, soggetto ai poteri dell’unico Consiglio Superiore, non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti…”.
Questo per dire che, salvo a voler considerare la stessa Corte eversiva dell’Ordine Costituzionale, lo slogan sbandierato è un atto irresponsabile.
Anche l’altro argomento, quello della perdita di indipendenza e autonomia esterna del P.M., è ingannevole. Per dimostrarlo basta leggere il testo del disegno di legge costituzionale, dal quale si comprende che non sarà possibile in alcun modo sottoporre il P.M. al controllo o alla volontà dell’Esecutivo o a quella del Ministro della Giustizia. Piuttosto, è da dire che sul tema la storia della magistratura e la psicologia insegnano che il magistrato corra sempre questo rischio, ciò a prescindere dalle norme che lo garantiscono: il fenomeno delle c.d. “porte girevoli” è sotto gli occhi di tutti; come lo è il fatto che il pericolo dipenda dal cedimento morale dell’individuo a favore di chi, di volta in volta, detiene il potere: sono l’ambizione, l’amore per il proprio ego, il desiderio di successo, quei diversi fenomeni interiori che in vario modo offuscano il limite etico di una persona, portando al superamento di ogni regola scritta diretta a evitarne il rischio.
Lo sapeva bene anche Pietro Calamandrei quando scriveva che “bisogna altresì togliergli [al magistrato] ogni speranza che un atteggiamento servile ed inchinevole possa giovare alla sua carriera futura… se il nostro ordinamento giudiziario riesce a proteggere il giudice contro le vendette, non riesce a proteggerlo contro un’arma più insidiosa e più penetrante, cioè contro i favori dei governanti”[7].
Questo condizionamento appartiene alla nostra storia recente, ma soprattutto questo è accaduto durante il regime fascista, dove, a fulgidi esempi di indipendenza e autonomia della funzione, si sono verificate situazioni di spregevole asservimento: a magistrati che hanno ceduto alle chimere del potere perdendone l’autonomia, come quel Gaetano Azzolini[8] che, proveniente dalla magistratura ordinaria, divenne Presidente del Tribunale della Razza e poi, caduto il regime, venne nominato primo presidente della Corte di Cassazione e poi Presidente della Corte Costituzionale, si contrapposero magistrati eroi. Questi fecero valere quei limiti etici che derivano dalla responsabilità della funzione, alla quale adempirono con coraggio e onore: tra i molti, va ricordato Mauro Del Giudice[9] che, indagando sull’omicidio del deputato Giacomo Matteotti, si rifiutò di accogliere le pressioni provenienti dal Partito unico e dai suoi stessi superiori, i quali pretendevano che l’omicidio volontario dell’esponente socialista venisse degradato a omicidio preterintenzionale.
Menzionare questo luminoso e valoroso esempio di magistrato, con la sua autonomia e indipendenza interna ed esterna, è un dovere e va fatto riportando le sue parole, rese a verbale quando, caduto il fascismo, la vicenda giudiziaria che lo aveva visto protagonista si riaprì: “Allora gli dissi chiaro e aperto: che avevo capito ciò che si pretendeva da me e che io non mi sarei mai prestato a simili ribalderie, giacché alla infamia pubblica, io preferivo la persecuzione, la miseria, ed anche, occorrendo, la morte”.
Considerare la riforma come pericolosa per l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati, dunque, è una forma di conservatorismo, così come ci ricorda il confronto tra l’attuale posizione dell’ANM con quella che essa ebbe quando, il 23.1.1947[10], si espresse rispetto alle norme proposte dalla Commissione dei 75: “inficiano i due presupposti essenziali e inderogabili di un vero e proprio potere giudiziario, vale a dire l’unità della giurisdizione e l’indipendenza ed autonomia della magistratura”[11].
- B) “Con le carriere separate si finisce per allontanare il P.M. dalla giurisdizione… avvicinandolo alla polizia giudiziaria e facendolo diventare un superpoliziotto”.
È necessario qui intendersi sui termini utilizzati: quest’affermazione forse significa che, con la separazione, il P.M. si allontanerà dalla “cultura della giurisdizione”?
Come può essere vero ciò, se questa cultura è necessariamente propria di ogni soggetto del processo: appartiene al Giudice, quanto al P.M., all’avvocato e ai funzionari di cancelleria e segreteria, ma appartiene anche alla stessa polizia giudiziaria, poiché tutti, nell’azione pubblica diretta al perseguimento dell’oggetto e degli scopi del processo penale, operiamo imbevuti della cultura della legalità costituzionale.
C’è da chiedersi se piuttosto, davanti a queste affermazioni, non debbano offendersi le Forze di polizia, poiché l’art. 34 della L. 121 del 1981 (Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza) dispone che la Polizia di Stato “Esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l’esercizio della libertà e dei diritti dei cittadini…”, in un’evidente ottica di rispetto della legalità costituzionale senza la quale, inutile dirlo, non si può garantire la sicurezza dello Stato.
Quindi – nessuno ne ha mai dubitato – le forze di polizia si collocano nell’alveo della cultura della legalità costituzionale e, dunque, il P.M., avvicinandosi a loro, non ne potrebbe mai fuoriuscire. Piuttosto va ribadito che, nel corso delle indagini, il P.M., già oggi, dispone della polizia giudiziaria e la dirige nel compimento delle stesse, con un interscambio di notizie e azioni continuo e sistematico e, nonostante ciò, nessuno di loro ha mai paventato questo pericolo.
Aggiungo che, se alcune persone appartenenti alle forze di polizia – come dimostrano alcuni gravi fatti di cronaca – a volte mostrano limiti di cultura della legalità costituzionale, l’avvicinamento a chi, come il P.M., per formazione e provenienza, ne è pienamente e formalmente impregnato, farebbe bene a quegli stessi individui e i cittadini ne trarrebbero grande beneficio.
- C) “Cos’è poi quello strano oggetto della nuova Corte che dovrebbe giudicare tutti i magistrati per le violazioni disciplinari?… con questa riforma si attenta all’unità della giurisdizione… Pietro Calamandrei, padre del testo costituzionale, davanti a queste proposte si starà rivoltando nella tomba”.
L’uso di questi slogan – sollecitando a vantaggio della propria opposizione l’autorevolezza di Pietro Calamandrei – dimostra che chi le richiama conosce grossolanamente le idee del grande Maestro.
Sappiamo che l’attuale testo costituzionale, inizialmente minoritario, è il frutto della proposta del Calamandrei, nonché di una serie di coincidenze politiche e situazionali[12] che, in Costituente, fecero convergere su quello i comunisti, i socialisti e i democristiani i quali, sul tema, già nella Commissione dei 75, avevano avanzato proposte completamente diverse.
Per quel che qui interessa, volendo sintetizzare l’iniziale proposta del Calamandrei[13], essa prevedeva, oltre a una “Suprema Corte disciplinare”[14] presso il CSM, anche la “Corte disciplinare regionale”, organi questi deputati a giudicare sulle violazioni disciplinari dei magistrati[15].
Non solo, ma Calamandrei, al quale si deve l’idea della “unità della giurisdizione”, quando la sosteneva non si riferiva affatto all’appartenenza del P.M. e del Giudice allo stesso Ordine, ma alla necessità che nel nuovo assetto giurisdizionale venissero eliminate le giurisdizioni amministrativa e contabile, in favore di un’unica giurisdizione ordinaria che le comprendesse tutte, pur con delle specializzazioni per le differenti materie[16].
Se le cose stanno così, e volessi disturbare il riposo di un Grande, direi che Calamandrei si starà fortemente indignando con chi prova a tirarselo impropriamente dalla sua parte.
- D) “Questa proposta è la stessa che volevano realizzare Lucio Gelli e quelli della P2… si tratta di una idea che intendeva conseguire anche Silvio Berlusconi… Giovanni Falcone non ha mai sostenuto la separazione delle carriere, come sostengono i fautori della stessa”.
Con la prima affermazione si dimostra di ignorare le dinamiche storiche della proposta, con la seconda, chi la sostiene, non conosce le ragionate e chiare parole del dott. Falcone.
Quanto alla prima, nel secolo scorso[17] l’idea di una distanza tra il giudice e il propugnatore “dell’istanza di giustizia”, il P.M. per intenderci, era già presente nel programma politico del PSI di Turati, presentato dal Segretario per le elezioni del 1919. Si voleva che il giudice, a differenza del P.M., venisse eletto dal Popolo.
In quello stesso anno, a rafforzamento di quella nuova idea, sulla Rivista Penale usciva un articolo dal titolo “Il Pubblico Ministero è parte” a firma di Giacomo Matteotti[18], il quale già allora, vigente un diverso sistema processuale, da grande politico qual era, anticipava, criticandole, quelle stesse osservazioni che oggi vengono propugnate dai contrari alla separazione: il p.m., dicevano quelli, “agisce nel processo non per un interesse egoistico o personale, ma per fini di giustizia e per un interesse collettivo o generale, che lo avvicina più al giudice che alle parti”; “nel processo esso rappresenta la collettività e dunque quella stessa dello Stato, in nome del quale il magistrato deve giudicare”; “il p.m. non agisce necessariamente in contrasto con quelli della parte accusata, ma per fini superiori di giustizia, per il rispetto e l’osservanza della legge… assumendo nel processo una posizione più nobile e imparziale, al di sopra delle parti”. Matteotti, concludendo il suo ragionamento critico rispetto a queste pretese, scriveva: “Così rettamente interpretate, nessuna delle norme di procedura si oppone, anzi tutte confermano la qualità di parte del p.m., o, più esattamente, la sua qualità di organo della collettività, che nel processo entra come parte offesa dal reato e portatrice dell’azione penale contro il delinquente”.
Eravamo nel 1919, più di un secolo addietro e le idee sul tema erano già chiare e decisive; da allora sono cambiati tre codici di procedura penale, l’ultimo del quale avrebbe imposto, come voleva fare il Ministro Giuliano Vassalli, che il P.M. e il Giudice appartenessero a Ordini diversi.
Il dibattito proseguì anche nel corso della Costituente, dove i comunisti, con Palmiro Togliatti[19], e Fausto Gullo[20], freschi del programma loro imposto dalle decisioni del V° Congresso del partito[21], nella Commissione dei 75 sostennero che i Giudici venissero eletti, mentre la DC, con Giovanni Leone, pur opponendosi alla elezione popolare dei magistrati, proponeva un P.M. come “organo del potere esecutivo”, “posto a capo della polizia, non solo giudiziaria” e “alla dipendenza gerarchica del Ministro della giustizia”.
Queste proposte, direi fortunatamente, non hanno trovato l’accordo nella maggioranza dei Costituenti, soprattutto per i gravi contrasti politico-governativi emersi tra comunisti e socialisti da una parte e democristiani dall’altra, e dunque prevalse la proposta Calamandrei. Ma di quella volontà maggioritaria, di porre su piani diversi le due funzioni della magistratura, c’è prova evidente nella formula utilizzata nell’art. 101 della Costituzione: “I giudici sono soggetti alla legge” e non anche i P.M., diversamente da quanto disposto nel testo redatto dalla Commissione dei 75, che invece faceva riferimento a “tutti i magistrati”.
Questo è il quadro nel quale si mossero i Costituenti, e allora lascerei da parte tanto Licio Gelli, la sua P2 e Silvio Berlusconi. Piuttosto segnalo lo scopo evidentemente perseguito dai sostenitori di questo slogan: tentare di criminalizzare o mettere in cattiva luce coloro che oggi – in tempi in cui il rosso simbolico si è del tutto scolorito – propugnano la separazione delle carriere.
Analoga inesattezza cela in chi sostiene che “Giovanni Falcone non ha mai propugnato la separazione delle carriere”.
Invece Falcone lo ha fatto in almeno due occasioni pubbliche: il 28 luglio 1988, nel corso di un suo intervento a un convegno promosso da Mondo Operaio e, successivamente, il 3 ottobre 1991, in un’intervista rilasciata a Mario Pirani, pubblicata su “La Repubblica”.
Non fu affatto un’affermazione istintiva e decontestualizzata, ma del tutto ragionata e preziosa in punto di diritto, e alla quale è molto difficile opporre argomenti giuridici e politici contrari: “La questione centrale” affermava Falcone, “che non riguarda solo la criminalità organizzata, sta nel trarre tutte le conseguenze sul piano dell’ordinamento giudiziario che il passaggio dal processo inquisitorio al processo accusatorio comporta. Se questa riforma dell’ordinamento non sopravviene rapidamente il nuovo processo è destinato a fallire[22]. Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono, quindi, esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l’obiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di para-giudice. Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e Pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell’esecutivo. È veramente singolare che si voglia confondere la differenziazione dei ruoli e la specializzazione del Pm con questioni istituzionali totalmente distinte. Gli esiti dei processi, a cominciare da quelli di mafia, celebrati col nuovo rito, senza una riforma dell’ordinamento, sono peraltro sotto gli occhi di tutti”.
Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro, se non che una parte di quelli che, all’interno della magistratura, lo boicottarono, continua a opporsi alle sue idee.
- E) “Perché sprecare tante energie con una riforma costituzionale quando il numero di magistrati che passa da una funzione all’altra e meno dell’1%?… Evidentemente il fine perseguito dai riformatori è diverso”.
Anche queste asserzioni si scontrano con il rigore logico, e così si tenta di dare all’opinione pubblica una rappresentazione negativa del Legislatore al quale, indipendentemente dalle idee politiche perseguite, bisogna riconoscere il rispetto proprio di ogni Istituzione, Ordine giudiziario compreso.
Intanto, che siano pochi i magistrati a migrare da una funzione all’altra non significa affatto che domani, invece, non siano molti a farlo. E come ben ricorda un autorevole magistrato ancora avvezzo alle TV, la politica consiste nel saper prevedere le difficoltà future e prevenirle. Poi è da dire che, nella pratica, questa scarsa propensione allo scambio, non rompe affatto la commistione tra le due funzioni a danno del Giudice, il quale è valutato dai P.M. nella sua progressione di carriera, nei trasferimenti, nelle domande che riguardano il suo profilo professionale. Senza contare che i P.M. siedono nei Consigli Giudiziari e nel CSM: dare torto al P.M., dunque, può avere potenziali conseguenze sulla carriera del Giudice e dunque condizionarlo, quando non anche determinare gravi situazioni come quelle descritte nel mio ultimo romanzo.
Non posso fare a meno di citare ancora quanto sosteneva Mario Pagano: “Il timore attacca la libertà nella sua stessa sorgente”. E che il timore, anche inconscio, del giudice possa trarsi dalla presenza, a volte asfissiante, del P.M., consegue logicamente anche da quello che di questo magistrato recentemente ha scritto Giovanni Canzio: “forte di un indebito intreccio di relazioni con gli organi di stampa e dei media, a comunicare e valorizzare l’ipotesi accusatoria e il suo operato attraverso tali organi, o nel contesto di social network e talk show, relazionandosi direttamente con il popolo e con la politica, persino con l’esecutivo. “Porte girevoli” invero censurabili, questa, grazie alle quali il pubblico ministero, al di là e fuori del suo ruolo istituzionale, viene ad assumere l’impronta e spesso inadeguata veste di prevalente – se non esclusivo – storyteller dei casi e delle questioni di giustizia, di cui si fa rappresentante o addirittura promotore di revisioni legislative ad hoc, anziché operare nel contesto storico-spaziale e secondo le regole del procedimento o del processo”[23].
La verità, dunque, sta nel fatto che il P.M. con la riforma teme di perdere questo ruolo di prima donna, e con esso il grande e incontrollato potere che ne deriva. Separarne le carriere, assicurando davvero a entrambi autonomia e indipendenza esterna e interna, significa dare al giudice un ruolo centrale nel processo penale, funzione che gli spetta quale soggetto deputato a giudicare rispetto alle domande di giustizia che provengono dal P.M., facendolo in una posizione di terzietà e imparzialità anche rispetto alla parte pubblica, come si pretende in un sistema processuale accusatorio e, peraltro, come sta scritto nella Costituzione che si suole sbandierare a sproposito.
Una riforma che non è un attacco all’autonomia e all’indipendenza dei magistrati – noi avvocati saremmo i primi a impedirlo! – come è evidente a tutti coloro che scrupolosamente si sono imbattuti dapprima nel disegno di legge di iniziativa popolare presentato dall’Unione delle Camere Penali nella passata legislatura e ora, nel testo di iniziativa governativa. La previsione di un doppio CSM, uno per i PM e l’altro per i soli Giudici, con la maggioranza in entrambi gli Organi dei componenti togati, è la garanzia assoluta e indissolubile della loro indipendenza e autonomia.
Peraltro, nella pur quotidiana discussione non è mai emersa, esplicitandosi, la modalità con la quale la riforma consentirebbe interferenze dell’Esecutivo e del Ministro della Giustizia sui Pubblici ministeri.
Mi dispiace solo che a rispondere agli interventi di tante autorevoli personalità, non si inviti nessuno pronto a ricordare loro l’ingiustizia in cui versa il servizio penale, citando, per sostenerlo, le centinaia di suicidi, in gran parte di persone in attesa di giudizio, che ogni anno cadono all’interno delle nostre carceri e portando la voce di quelle decine di migliaia di cittadini che, per essere “riparati” dalla ingiusta detenzione subita, ciascuno con un miserabile assegno, sono costati allo Stato più di un miliardo di euro.
Anche a costoro, alle loro famiglie, e non solo a loro, gli avvocati penalisti hanno il dovere di dare voce, sostenendo con determinazione questa riforma costituzionale[24].
[1] La7, L’aria che Tira, 30.12.24: https://www.la7.it/laria-che-tira/video/fiducia-nella-magistratura-il-sondaggio-di-alessandra-ghisleri-gli-italiani-hanno-paura-della-30-12-2024-573589.
[2] Se così non fosse la magistratura non avrebbe più la legittimità sostanziale che, insieme a quella formale, le consente di privare i propri simili della libertà e dei loro degli averi.
[3] L’espressione completa è: “Gli slogan devono essere ripetuti continuamente, finché anche l’ultima persona sia arrivata a coglierne l’idea”; Adolf Hitler, Mein Kampf, Berlino, 1943. Un altro esempio recente della validità di questo metodo, sono gli esiti della campagna presidenziale degli USA, dove di falsi slogan, ripetuti continuamente, si è fatto con successo larghissimo uso.
[4] L. Hasher, D. Goldstein, T. Toppino, “Frequency and the conference of referential validity”, in Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 16 (1), 1977, pp. 107 – 112.
[5] Sulle ragioni per le quali “L’abitudine ci rende ciechi” si veda: Tali Sharot, Cass R. Sunstein, Guardate meglio, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2024.
[6] Sono tanto numerosi i magistrati e i politici che usano questi slogan che indicarne solo alcuni, significherebbe mancare di rispetto agli altri. Per conoscerli basta accedere alle fonti aperte.
[7] Riportato in “Governo e Magistratura”, in Opere Giuridiche, a cura di Mauro Cappelletti, Napoli, 1966, vol. II, p. 208.
[8] Si veda, Marcello Flores e Mimmo Franzinelli, Conflitto tra Poteri. Magistratura, politica e processi nell’Italia repubblicana, Il Saggiatore, Milano, 2024.
[9] Costantino De Robbio, “A margine del Processo Matteotti: la coerenza di un magistrato in tempo di regime”, in “Giustizia Insieme”, 6 aprile 2024.
[10] Da segnalare che una delle proposte di cui si fece portatrice l’ANM – “inaccettabile”, come disse il Calamandrei – fu quella di prevedere l’immunità penale per i singoli magistrati. Sul punto si veda Augusto Barbera, “Calamandrei e l’ordinamento giudiziario: una battaglia su più fronti”, nella sua Relazione fatta al convegno “Pietro Calamandrei e la ricostruzione dello Stato democratico”, tenuto presso l’Università di Firenze, 18.2.2006, in Rassegna parlamentare, 2006. Quanto ai sostenitori di questa proposta in Costituente, si vedano gli Atti dell’Assemblea Costituente, seduta pomeridiana del 26.11.1947, pp. 4116 e ss.
[11] Gianfranco D’Alessio, Alle Origini della Costituzione italiana, Il Mulino, Bologna, 1979, p. 253.
[12] Basti pensare che la collaborazione tra democristiani e comunisti si interruppe bruscamente quando la Democrazia Cristiana formò un nuovo Governo, escludendo da quel Gabinetto gli esponenti del PCI e dei Socialisti.
[13] Sul punto si veda la “Relazione sul potere giudiziario e sulla Corte Costituzionale”, elaborata nel 1946 dal Calamandrei su incarico della Commissione dei 75.
[14] La Suprema Corte Disciplinare era già prevista dalla L. n. 138/1908.
[15] Si vedano gli artt. 17 e 18 della Relazione Calamandrei redatta per la Commissione dei 75.
[16] Calamandrei spiegava così il suo concetto: “Nel senso di attrarle tutte quante nell’ambito della magistratura ordinaria, sicché tutti i loro componenti, a cominciare dai membri delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, siano per reclutamento, e per garanzie di indipendenza, in tutto parificati ai magistrati ordinari”, in Governo e Magistratura, op. cit. p. 219.
[17] Per una panoramica dei diversi interventi normativi fatti prima del regime fascista si veda, Pasquale Iasuozzo, “Considerazioni su politica e magistratura nella transizione dall’esperienza liberale a quella fascista”, in Nomos, l’attualità nel diritto, n. 3 del 2022.
[18] G. Matteotti, “Il Pubblico Ministero è parte”, in Rivista Penale, Torino, 1919, vol. XC, dispensa 413-415.
[19] Togliatti riteneva che l’autogoverno dei magistrati fosse una “concezione democraticamente inaccettabile” e, intervenendo nel dibattito generale sul progetto di Costituzione l’11.3.1947, aggiunse che esso riguarda: i “sovrani senza corona e senza autorità”.
[20] Gullo, sull’autogoverno sosteneva che non era possibile costituire per i P.M. una guarentigia autoreferente “propria di una casta”.
[21] Congresso tenutosi a Roma dal 29 dicembre 1945 al 5 gennaio 1946.
[22] A me sembra che questo presagio, si è puntualmente realizzato.
[23] Giovanni Canzio, “Il Pubblico Ministero, parte imparziale?” in Questione Giustizia, fascicolo 1/2, 2024.
[24] Riguardo la funzione politica del penalista, si veda il mio pamphlet: ”Manifesto per un’azione politica dell’avvocato penalista”, scritta per il periodico Antilogi E, Napoli 16.5.2016.
potrebbero interessarti…
News dalle Sezioni Unite
…entra

Gli approfondimenti…
Contatti
Iscrivendoti alla nostra Newsletter acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni, clicca qui