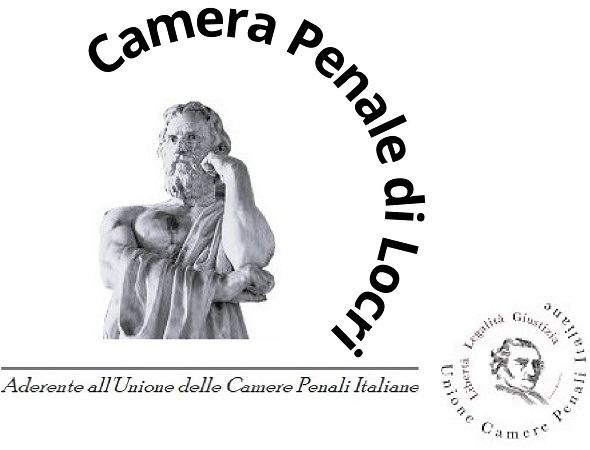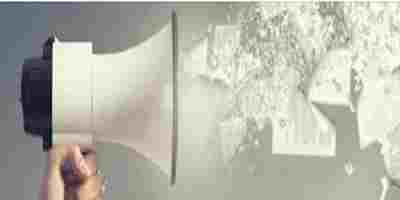La sesta sezione penale della Suprema Corte, con la pronuncia in questione, ha gettato le basi per un significativo cambio di direzione in ordine alla definizione dei parametri interpretativi idonei a distinguere le condotte che integrano il reato di corruzione da quelle che configurano il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione stabilendo che “in tema di corruzione la mera accettazione da parte del pubblico agente di un’indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale – e dunque la violazione del generale principio di imparzialità – non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l’esercizio dell’attività sia stato condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l’interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l’esercizio della funzione”.
E, ancora, i Giudici di legittimità, in tema di configurabilità del delitto di concussione, hanno rilevato che “non integra la fattispecie di concussione la condotta di semplice richiesta di denaro o altre utilità da parte del pubblico ufficiale in presenza di situazioni di mera pressione ambientale, senza però che questi abbia posto in essere atti di costrizione o d‘induzione, non potendosi fare applicazione analogica della norma incriminatrice, imperniata inequivocabilmente sullo stato di soggezione della vittima provocato dalla condotta del pubblico ufficiale”
La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato L. A. – in relazione al reato di corruzione per l’esercizio della funzione – per intervenuta prescrizione e nei confronti dell’imputato I.S.V., in relazione a due ipotesi delittuose (confluite nel medesimo capo di imputazione) – afferenti il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio – per essersi i medesimi estinti per prescrizione. Il giudice di secondo grado rideterminava la pena nei confronti di I.S.V. in anni quattro di reclusione, revocava la confisca disposta nei confronti di L.A. pari a euro 6.500 e rideterminava la pena nei confronti di altro imputato (A.M.) in anni quattro di reclusione previa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte confermava nel resto l’impugnata sentenza e condannava, anche, la società “(…) S.R.L.” alla sanzione di 100 quote da 300 euro cadauna e la confisca del profitto per un importo pari a euro 115.000.
Ciò posto, per una migliore comprensione dell’intera vicenda, devesi evidenziare il ruolo svolto da ognuno degli imputati in relazione ai quali la Corte di appello di Milano ha affermato la penale responsabilità.
L’imputato L.A. rivestiva il ruolo di “ingegnere, dirigente del Comune di Milano incaricato della direzione del settore tecnico che si occupava di edilizia patrimoniale e demaniale e incaricato della direzione del servizio edilizia scolastica, nonchè direttore del settore che aveva predisposto il progetto che avrebbe realizzato l’opera e componente della “commissione anomalie”.
L’imputato I.S. ricopriva il ruolo di “architetto del Comune di Milano facente parte della direzione centrale opere pubbliche e centrale unica appalti, responsabile dell’unita/servizio sociale progetti e inserito nel gruppo per la valutazione delle offerte anomale come esperto dell’analisi tecnica delle anomalie”.
Infine, l’imputato A.M. era “titolare di posizione organizzativa presso la Direzione centrale settore tecnico scuole e strutture sociali del Comune di Milano e direttore dei lavori dell’appalto 69 aggiudicato alla società “(…) S.R.L.”.
I medesimi, per il tramite dei rispettivi difensori, proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado.
La sesta sezione, investita dei relativi atti di gravame, reputava parzialmente fondati i ricorsi presentati dai soli imputati I.S.V. e A.M..
Il primo – tra i vari motivi di doglianza – lamentava l’erronea qualificazione giuridica dei fatti (delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio) al medesimo contestati e rispetto ai quali era stata emessa sentenza di condanna.
Il secondo ha eccepito l’erronea qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto pienamente configurato il reato di concussione al medesimo contestato. In tal senso, l’imputato A.M. si duole del fatto che, dalla globale disamina dei fatti, non è emersa alcuna condotta minacciosa e costrittiva posta in essere dall’imputato nei confronti di altro soggetto (giudicato separatamente) che non risultava essere il titolare dell’ impresa asseritamente concussa, ma una sorta di intermediario della pretesa concussiva. Inoltre, dall’analisi dell’enunciato imputativo emergeva una evidente incompatibilità tra l’accertata esistenza delle condotte corruttive, riferite al medesimo appalto, a carico degli imputati L.A e I.S in concorso con altro soggetto (giudicato separatamente).
Ciò posto, secondo i giudici di legittimità, ha colto parzialmente nel segno il ricorso presentato dall’imputato I.S.V. dal momento che la Corte di appello di Milano:
- avrebbe proceduto a una errata qualificazione giuridica dei fatti (secondo la Corte di Cassazione, i giudici del merito avrebbero erroneamente qualificato a livello giuridico i fatti facendoli rientrare all’interno del delitto di “corruzione propria”);
- non avrebbe specificamente indicato l’atto contrario ai doveri d’ufficio;
- avrebbe convalidato l’opzione ermeneutica adottata dai giudici di primo grado che – avallando l’impostazione accusatoria secondo cui la condotta criminosa dell’imputato I.S.V. si sarebbe estrinsecata nell’ “assegnazione di appalti avvenuta con violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e con l’inosservanza delle norme procedimentali relative ai criteri di scelta dei contraenti” – avevano individuato “l’atto contrario ai doveri d’ufficio” (asseritamente commesso dal ridetto I.S.V.) nella “redazione di giustificazioni dell’impresa che avrebbe dovuto vincere i singoli appalti in base agli accordi”.
Tale motivazione, ad avviso della sesta sezione, non può reputarsi adeguata.
In tal senso, devesi evidenziare che i Giudici di legittimità hanno dato seguito al principio già stabilito dalla stessa sezione (cfr. Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019 – dep. 2020, Bolla) secondo cui “in tema di corruzione la mera accettazione da parte del pubblico agente di un’indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale – e dunque la violazione del generale principio di imparzialità – non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l’esercizio dell’attività sia stato condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l’interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l’esercizio della funzione”.
Il ragionamento logico-giuridico dianzi esposto si fonda sul fatto che, ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa di “corruzione propria”, è necessario che il soggetto agente abbia commesso uno specifico atto in contrasto con i propri doveri d’ufficio (art. 319 c.p.). Tale precisazione è di assoluto rilievo atteso che, in assenza del ridetto atto contrastante con i doveri d’ufficio, è ravvisabile la meno grave ipotesi delittuosa prevista dalla norma contenuta nell’art. 318 c.p. (corruzione per l’esercizio della funzione).
Tale operazione ermeneutica si pone – come sottolineato dalla sesta sezione – in contrasto con l’opposto filone giurisprudenziale (condiviso, nel caso di specie, dai giudici del merito) secondo il quale devesi “considerare atto contrario ai doveri di ufficio la mera “strumentalizzazione” o “distorsione” dell’esercizio del potere discrezionale stesso, derivante dalla circostanza che il pubblico ufficiale è stato remunerato dal corruttore e ne “ha preso in carica l’interesse”, senza operare una adeguata ponderazione degli interessi coinvolti nella decisione di sua spettanza”. Di tal che, secondo l’opposto orientamento di legittimità, “sussiste sempre la corruzione propria, anche se l’atto in cui si sostanzia tale esercizio non è in sé contra legem”.
Orbene, la Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha sottolineato il rischio derivante da tale tipo di approccio interpretativo ossia quello di “azzerare in relazione all’esercizio di potere discrezionale lo spazio applicativo della fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen. (come modificata dal legislatore del 2012), atteso che in tal modo si verifica una, non consentita, espansione dell’ambito applicativo del reato ex art. 319 cod. pen. che non risulta in sintonia con il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penale” (cfr. Corte Cost., sent. n. 98 del 28 aprile – 14 maggio 2021, secondo cui “sono le norme incriminatrici – non già la loro successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza – a dover «fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte; sicché non è tollerabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore”. Difatti, “il divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici da parte del giudice costituisce il naturale completamento di altri corollari del principio di legalità in materia penale sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., e in particolare della riserva di legge e del principio di determinatezza della legge penale”).
Con riferimento al ricorso proposto da A.M, questi è stato reputato parzialmente fondato con specifico riferimento alla censurata qualificazione giuridica dei fatti operata dalla Corte di appello di Milano.
Difatti, secondo il Supremo Collegio, i giudici di secondo grado non hanno fornito una adeguata motivazione per ritenere sussistente il delitto previsto dalla norma contenuta nell’art. 317 c.p.. In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato come “non integra la fattispecie di concussione la condotta di semplice richiesta di denaro o altre utilita da parte del pubblico ufficiale in presenza di situazioni di mera pressione ambientale, senza però che questi abbia posto in essere atti di costrizione o d‘induzione, non potendosi fare applicazione analogica della norma incriminatrice, imperniata inequivocabilmente sullo stato di soggezione della vittima provocato dalla condotta del pubblico ufficiale” (cfr. sent. n. 25694 dell’11/01/2011, De Laura).
Ciò posto, la sesta sezione si è soffermata sulla distinzione tra il delitto di concussione e quello di induzione indebita rilevando che “in tema di concussione di cui all’art. 317 cod. pen., cosi come modificato dall’art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciatogli; ne consegue che non è sufficiente ad integrare il delitto in esame qualsiasi forma di condizionamento, che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare una coercizione psicologica cogente in capo al soggetto passivo” (cfr. Sez. 2, n. 23019 del 05/05/2015, Adamo).
Infine, con specifico riferimento alla distinzione intercorrente tra il reato di corruzione e quelle di concussione e induzione indebita, devesi rilevare che “il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre “l’extraneus”, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l’accordo corruttivo presuppone la “par condicio contractualis” ed evidenzia l’incontro libero e consapevole della volontà delle parti”.
Pertanto, alla luce dei principi di diritto superiormente esposti, la Suprema Corte ha disposto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza ad altra sezione della Corte di appello di Milano al fine di chiarire se il rapporto intercorso tra le parti (ossia tra il pubblico ufficiale e il privato fiduciario del titolare dell’impresa che era interessato all’appalto) possa essere qualificato in un’ottica di effettiva e concreta disparità di posizione o in un’ottica squisitamente paritaria.
Di tal che, accedendo alla prima ipotesi (disparità di posizione), secondo il Supremo Collegio, i fatti andrebbero sussunti all’interno della fattispecie incriminatrice prevista dalla norma contenuta nell’art. 318 c.p..
Invece, accedendo alla seconda ipotesi (posizione paritaria tra le parti), sarà necessario – secondo la Corte – verificare se dal compendio probatorio emerga una condotta costrittiva da parte del p.u. tale da configurare il delitto di concussione o una induzione finalizzata a ottenere denaro dal coimputato A. e un indebito vantaggio per la società rappresentata dal privato (giudicato separatamente).
potrebbero interessarti…
Gli approfondimenti…
News dalle Sezioni Unite
…entra

Iscrivendoti alla nostra Newsletter acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Concessione del consenso per ricevere esclusivamente approfondimenti di interesse giuridico. Per ulteriori informazioni, clicca qui