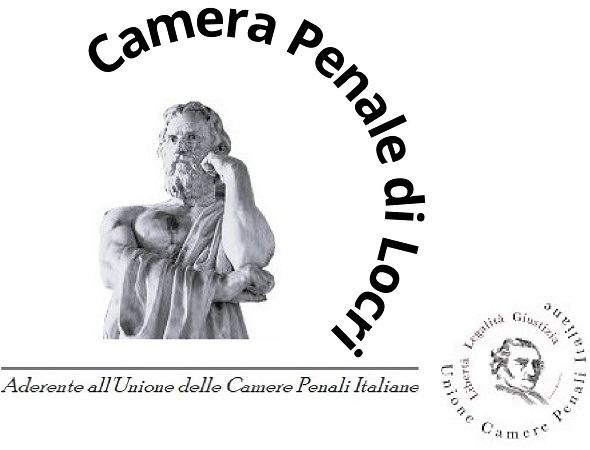Quando l’amico Peppe Calderazzo mi ha chiesto se avessi piacere a dare un contributo alla bella idea della Camera Penale di Locri di animare, sul proprio sito, un dibattito sui temi più caldi in materia di giustizia, ho detto subito sì. Senonché, poi, mi sono reso conto che non avevo alcuna idea su come poter “contribuire”. Anche se Peppe, con la consueta gentilezza, non mi aveva imposto di affrontare un argomento specifico. L’altra mattina, però, ho preso parte ad uno degli incontri organizzati in occasione del “Salone della Giustizia”.
La nota manifestazione che, ogni anno e da anni, richiama tutte le componenti sociali – e quindi politici (in primis il Ministro della Giustizia), giornalisti, magistrati – a confrontarsi su un tema fondamentale per il Paese.
L’oggetto del dibattito del mio incontro era quello, attualissimo, della violenza di genere.
Con me il Procuratore Menditto, che per reati del c.d. “codice rosso” ha una meritoria dedizione, la Senatrice Campione, componente della Commissione Giustizia del Senato, il comandate dello SCO della Polizia di Stato Marco Martino e, in veste di moderatore, il Direttore de Il Dubbio, Davide Varì.
Bene, devo dire che è stato quello scambio di vedute, o meglio il suo andamento, a farmi capire quale doveva essere l’argomento da condividere con i miei cari amici e conterranei Locresi.
Difatti, sebbene il dibattito fosse cominciato con una assoluta compartecipazione, tra tutti quelli che vi prendevamo parte, dei valori difesi dalle norme sostanziali che disciplinano la materia, mi era rimasta impressa la incredibile sensazione di mancanza di attenzione, da parte dei miei interlocutori, rispetto al problema della singolare “atipicità” delle regole processuali che devono applicarsi per quel tipo di reati.
Un classico esempio di processo da celebrare secondo le regole del c.d. “Doppio Binario”.
Ora, il primo problema che sorge quando si cerca di commentare qualcosa – ed io di “doppio binario” mi appresto a scrivere – è quello di definire questo qualcosa.
E una definizione certa della procedura che deraglia (così si comincia a capire come la penso) dalla via ordinaria per seguire altre regole, in effetti, non esiste.
Né esiste un codice o una raccolta di norme che racchiuda, in modo organico, le regole processuali da adottare per alcuni reati considerati di grave allarme sociale.
Alla fine, quella che mi pare più pertinente, è una definizione data nel 2001 dalla Corte di Cassazione (significativamente il ricorrente era il noto Bagarella), secondo cui saremmo in presenza di “una sorta di filo rosso che, collegando tra loro le varie disposizioni di legge destinate ad operare nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata consente di individuare, per differenza rispetto al regime processuale ordinario, le linee qualificanti una diversa e più adeguata disciplina processuale”.
Ecco, l’aggettivo “adeguata” credo racchiuda la ratio ispiratrice delle varie norme processuali che, secondo il legislatore, distonicamente rispetto alle regole del “Giusto processo”, necessitano di essere applicate per determinati reati.
Diventa allora necessario fare un passo indietro. E poi fare una considerazione persino banale. Cos’è un processo e qual è la sua funzione? La sua vera funzione vorrei aggiungere.
Bene, contrariamente ad alcuni fraintendimenti, il processo è un meccanismo mediante il quale una comunità di Uomini si propone di fare Giustizia (che poi ci riesca effettivamente è un’altra cosa). E quindi in primo luogo e fondamentalmente, si propone di stabilire se un determinato soggetto abbia posto in essere, in un passato recente o anche (frequentemente) remoto, una determinata condotta, commissiva od omissiva (in un secondo momento si ragionerà se quella condotta corrisponda ad una norma incriminatrice e poi ancora in ordine alla sussistenza di ulteriori requisiti necessari ad infliggere una sanzione).
Quindi non è uno strumento di lotta al crimine, non è un mezzo per garantire la pace sociale, né tantomeno un sistema per tutelare l’ordine pubblico.
Serve, sostanzialmente, ed appunto banalmente, per capire se un certo “fatto”, quello descritto nell’imputazione, sia realmente accaduto.
Ed ora un’altra enorme banalità. Qualunque uomo sottoposto ad un processo è innocente fino a prova contraria. E sarà l’esito di quel meccanismo, appunto il processo, a stabilire se viceversa sia colpevole.
E questo vale sia che l’uomo in questione sia accusato del furto di una caramella, sia che sia accusato del più repellente dei crimini.
Ora, in coerenza a quello che ci siamo detti, va ancora aggiunto che lo scopo principale delle regole processuali, non è quello di fornire delle garanzie all’imputato. Quelle regole, in realtà, sono da noi giudicate il miglior sistema per accertare, nel miglior modo possibile, se ciò che viene contestato nel corpo di una imputazione sia effettivamente accaduto. Le garanzie concesse all’imputato sono delle conseguenze. E questo perché si ritiene che non si possa ricostruire al meglio ciò che è accaduto in passato, senza ascoltare nella sede processuale la voce dell’imputato. Insomma il “contraddittorio” è anch’esso funzionale ad avere un prodotto finale di migliore qualità.
Si tratta di regole che sono frutto di una epocale svolta tecnica e soprattutto culturale, che progressivamente si è andata affermando in tutte le democrazie di stampo liberale, che ha messo da parte una gestione “autoritaria” della giustizia.
L’imputato era un “oggetto” all’interno del meccanismo. Gestito con autorevolezza da quelli che potevano essere considerati dei veri e propri sacerdoti del diritto: i magistrati. Non c’era motivo di un suo ruolo attivo, che avrebbe potuto solo disturbare il rito, perché i magistrati, anche quelli con ruolo di pubblico ministero, erano super partes e quindi svolgevano gli accertamenti anche nel suo interesse. In quest’ottica, tanto per dire, nonostante l’attuale Costituzione fosse vigente da svariati anni, si continuava a fare l’interrogatorio dell’imputato in assenza del suo difensore. Senza considerare
l’inscalfibile valore attribuito alle prove raccolte, nell’ “intimità” della caserma, da una “motivata” polizia giudiziaria.
Si è capito poi, e sempre di più, con un percorso che si è sublimato con l’introduzione dell’art. 111 della Costituzione, che l’uomo al centro dell’accertamento giudiziario doveva essere “il soggetto” di questo percorso. E ciò non solo perché aveva diritto a determinate garanzie. Ma anche, e forse soprattutto, perché il percorso di formazione della prova svolto senza un suo ruolo attivo, rischiava di consegnare al giudice, per la decisione finale, un prodotto avariato.
La presenza dell’imputato, in primis mediante il meccanismo del contraddittorio nella formazione della prova, garantiva una prova più affidabile.
E così possiamo chiudere un primo cerchio.
Per logica tanto più un processo risulta delicato, tanto più la pena da infliggere appare severa, tanto più il prodotto che determina l’esito dei quella procedura, appunto la prova, dovrebbe essere di prima qualità.
E questo – non lo dico io, ma le stesse norme – avviene quando si consente all’imputato di difendersi usufruendo di tutti i diritti garantiti dalle regole del “giusto processo”.
Ora, mediante il meccanismo del “doppio binario” processuale, si tradisce esattamente questo elementare principio di natura logica oltre che giuridica.
In determinati processi, stante l’oggetto dell’accertamento, può, per esempio, tradirsi la regola dell’oralità e dell’immediatezza (il riferimento è all’art. 190bis cpp).
E questa grave anomalia si giustifica con l’eccezionale rilevanza sociale del tema oggetto di processo.
Torniamo allora ancora indietro.
Perché erano “insensibili” e forse anche stupiti (per la verità con l’eccezione del direttore de Il dubbio Varì) i miei interlocutori e anche i ragazzi del pubblico durante il dibattito al Salone della Giustizia?
Perché dopo avere pienamente condiviso la necessità di prestare grandissima attenzione al fenomeno deprecabile della violenza di genere; alla necessità di creare dei meccanismi idonei a comprendere immediatamente l’esistenza di situazioni di particolare rischio; all’introduzione di una formazione specifica, per magistrati e soprattutto operatori di p.g. chiamati ad occuparsi di tale materia; ed avere infine convenuto sull’esigenza insopprimibile di lavorare sulla prevenzione, cercando di fare dei passi fondamentali verso una formazione culturale dei giovani che recepisca pienamente l’assoluta esigenza di colmare quello che ancora è ampiamente percepibile nel nostro contesto sociale, rispetto al problema di una effettiva parità di diritti; dopo avere ampiamente condiviso con i miei interlocutori tutto questo, cercavo disperatamente di affermare che la diversità di approccio doveva assolutamente arrestarsi alla soglia del processo.
Si chiedevano, soprattutto i meno esperti, perché il loro interlocutore, che non aveva fino a quel momento in alcun modo negato l’esistenza di un grave problema sociale, meritevole di una “particolare cura”, pretendesse, una volta giunti alla soglia del processo, che ogni influenza “emergenziale” fosse messa da parte? Che le regole del “giusto processo”, valessero pienamente anche in quel caso? Che non fosse in alcun modo auspicabile una diminuita capacità di difesa?
Ecco, tentavo di spiegare, che un’accusa infamante (come può essere per esempio un abuso sessuale), diventa un vero e proprio dramma quando si rivela fondata, ma al dramma già consumato (e per l’imputato questo si realizza nel momento in cui si assume tale veste) si aggiungerebbe la tragedia qualora un innocente fosse ingiustamente condannato.
Proprio perché è particolarmente grave ed infamante l’accusa, deve consentirsi al “soggetto” del processo di difendersi con le regole che sono state ritenute essenziali a pervenire ad una sentenza quanto più possibile giusta. Quanto più possibile affidabile.
Quello che colpisce e che tali temi, che a noi appaiono persino scontati, siano visti con sospetto dal contesto sociale.
Sicché credo che per farne trovare applicazione nella aule di giustizia sia assolutamente necessario cercare in tutti i modi di farli conoscere e divulgare al di fuori della ristretta cerchia di chi opera professionalmente nel campo giudiziario.
Tra l’altro, in quest’ottica, una ultima considerazione mi pare assolutamente necessaria.
Come nel campo naturalistico, ogni meccanismo idoneo a produrre elementi avariati, finisce, inevitabilmente, per estendere sempre di più il proprio il proprio campo di azione.
Il percorso delle misure di prevenzione lo testimonia in modo evidente.
Nate per essere applicante solo ed esclusivamente rispetto a contesti di grave criminalità organizzata, e per ciò solo giustificate – moralmente prima ancora che tecnicamente – rispetto alle gravi anomalie che le connotano, si sono progressivamente estese a tutta una serie incredibile di altre ipotesi.
E così accadrà e sta accadendo, per la casistica da regolare secondo le distonie del “doppio binario”.
Il compito di chi ha la capacità tecnica e anche la sensibilità (e dico sensibilità perché tocca con mano il dramma e la sofferenza di chi viene accusato) di comprendere il problema è quello di farlo capire ai “laici”.
Affinché grazie al prodotto processuale scadente che impone il doppio binario non si verifichi che chi sia stato ingiustamente imputato non venga anche ingiustamente condannato. Appunto: la doppia ingiustizia!
___________________________________________________________________________________________
Avv. Cesare Placanica (penalista Foro di Roma – ex presidente Camera Penale di Roma)
Iscrivendoti alla nostra Newsletter acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Concessione del consenso per ricevere esclusivamente approfondimenti di interesse giuridico. Per ulteriori informazioni, clicca qui